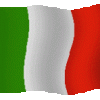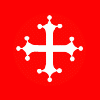-
Numero contenuti
19 -
Iscritto
-
Ultima visita
Tipo di contenuto
Profili
Forum
Calendario
Tutti i contenuti di Chersino
-

Chersino Racconta: L’Odissea Infinita Della Mia Prigionia
una discussione ha aggiunto Chersino in Gli Uomini
Eravamo nella primavera del 1945 ed era ormai chiaro che la resa della Germania era solo questione di giorni. Le truppe alleate erano sbarcate in Normandia e la Francia era stata rapidamente liberata. Ora avanzavano in Germania verso Berlino. Un giorno, dopo aver fatto con l’Olandese le consegne, ritorniamo al magazzino della ditta Johan Bunte a Papenburg e troviamo il proprietario disperato: i Tedeschi in ritirata gli avevano svuotato il magazzino e portato via tutti gli automezzi rimasti. Si era salvata solo la macchina personale del signor Bunte perché funzionava a gasogeno¹ e non erano stati capaci di metterla in moto. In quel frangente il signor Bunte dinostrò di essere davvero una brava persona: la sua attività commerciale era finita e non c’era più ragione che lui continuasse a tenerci. Allora mi regalò la sua automobile che io sapevo far funzionare perché in diverse occasioni gli avevo fatto da autista e l’Olandese si prese il piccolo camion con il quale facevamo le consegne, così tutti e due avevamo un mezzo con il quale tentare di tornarcene a casa. Lo ringraziammo commossi. Io presi un barattolo di vernice bianca e dipinsi una grande croce su entrambi gli sportelli anteriori della macchina (non avevo trovato della vernice rossa) per cercare di farla passare come un mezzo di soccorso; poi caricai due sacchi di carbonella e una batteria di scorta. Così, io davanti e l’Olandese dietro, ci dirigemmo verso la linea del fronte. Percorsi una sessantina di chilometri arrivammo a Meppen, in prossimità del confine con l’Olanda. Il mio compagno di viaggio si sentiva ormai a casa, mentre io progettavo di passare il confine olandese per poi scendere in Belgio, attraversarlo tutto e quindi passare la frontiera con la Francia per tornare a Bordeaux e ricongiungermi finalmente ad Edmonde. Purtroppo i nostri sogni ebbero breve durata, perché arrivati ad un ponte che attraversava il fiume Ems le truppe di occupazione scozzesi ci impedirono di proseguire, in quanto attraverso quel ponte dovevano transitare le autocolonne alleate dirette all’interno della Germania. A nulla valsero le nostre suppliche. Però, alla fine, un sottufficiale che sorvegliava il traffico del ponte, forse per aiutarci, ma molto più probabilmente per toglierci dai piedi, ci disse che poco più a monte c’era la possibilità di guadare il fiume. Ripartimmo subito seguendo le sue indicazioni e ci avventurammo nel letto del fiume, sempre io davanti e l’Olandese dietro col camion. Giunti a circa metà del guado il differenziale si incagliò su un sasso sollevando le ruote posteriori, cosicché rimasi immobilizzato. Intanto dalla parte opposta sopraggiungeva un’autocolonna alleata. Arrivati alla nostra altezza si dovette fermare. Dalla prima jeep scese un sergente americano che cominciò ad inveire contro di noi che stavamo intralciando l’avanzata. Nel giro di pochi minuti un grosso camion con sei ruote motrici si staccò dalla colonna e mi spinse senza tanti complimenti sulla sponda opposta. A questo punto la macchina non era più funzionante, ma l’avremmo dovuta comunque lasciare insieme al camion in una specie di cimitero d’auto che era stato creato a poca distanza dalla riva del fiume perché era consentito solo il traffico militare. Noi due ci caricarono su una jeep e ci portarono in un ex campo di concentramento tedesco dove venimmo alloggiati. Provammo una sensazione bellissima: eravamo finalmente liberi e potevamo girare a nostro piacimento per le vie di Meppen, dove le macerie di numerosi palazzi testimoniavano i bombardamenti cui l’avevano sottoposta gli alleati. Tornavamo nel campo di raccolta solo per mangiare e per dormire. Due giorni dopo ci radunarono assieme ad altri internati per farci i tesserini di riconoscimento. Io pensai che sarebbe stato meglio farne due: uno italiano con le mie vere generalità e uno francese con le stesse false generalità che erano riportate su una carta d’identità contraffatta che Edmonde mi aveva fatto fare dai maquisards² quando alloggiavo nella fabbrica di botti del padre. Questo perché io appartenevo alle forze armate dei “vinti” e, memore dei maltrattamenti che avevo subito dai Tedeschi, pensavo che all’occorrenza mi sarebbe convenuto farmi passare per Francese anziché per Italiano. Un’altra ragione era che avrei potuto approfittare del treno che sarebbe partito per primo diretto verso l’Italia o verso la Francia. Per la compilazione dei tesserini erano state destinate alcune baracche a seconda della nazionalità dei richiedenti. Così mi presentai dapprima alla baracca degli Italiani e detti le mie vere generalità, poi mi presentai a quella dei Francesi e dissi di chiamarmi André la Porta nato a Bayonne il 27 marzo 1920 (la data di nascita era l’unica cosa vera) e lì residente in rue de la Liberté 26 – in tutte le città francesi c’è una rue de la Liberté, quindi volevo essere sicuro di non essere preso in castagna. Bayonne è una cittadina sui Pirenei vicina al confine con la Spagna e i suoi abitanti parlano un francese un po’ imbastardito con lo spagnolo; la mia pronuncia francese, resa imperfetta dall’inflessione italiana, si avvicinava molto a quella dei Paesi Baschi e fu per questo che i maquisards mi “collocarono” a Bayonne. Infatti il giorno dopo chiamano tutti i Francesi ad una baracca del campo per il rimpatrio. Naturalmente mi sono aggregato anch’io congratulandomi con me stesso per la felice intuizione di essermi fatto fare anche il tesserino francese. Dopo averci dato delle razioni di viveri, ci hanno caricato sui camion e ci hanno portato a Maastricht, in Olanda quasi al confine con il Belgio, in una grande chiesa sconsacrata dove bivaccavano in totale promiscuità donne e uomini di numerose nazionalità. Siamo rimasti lì dieci giorni, poi ci hanno messo su un treno diretto in Belgio. Arrivati a Bruxelles ci hanno fatto scendere per chiederci chi voleva rimanere in Belgio a lavorare da libero cittadino. Alcuni Spagnoli hanno accettato, ma io non vedevo l’ora di tornare a Bordeaux. Alla sera stessa siamo arrivati a Charleroi, a poca distanza dal confine con la Francia. Ero felice: tra pochi giorni avrei potuto riabbracciare Edmonde. A Charleroi ci attendeva un plotone di paracadutisti per accompagarci in un campo di raccolta. Ci hanno dato un modulo di telegramma da inviare alla famiglia per dare nostre notizie, ma non potevo mandarlo a Edmonde o a casa mia a Cherso perché altrimenti avrebbero capito che le generalità che avevo dichiarato erano false. La mattina dopo fummo convocati per la discriminazione. Avanti a me c’erano tre francesi: entra il primo e gli domandano a quale compagnia apparteneva, chi era il suo comandante, dove aveva combattuto, dove lo avevano fatto prigioniero i tedeschi ed altre domande di dettaglio. Passa il secondo e si ripete lo stesso interrogatorio. E’ ora la volta del terzo che dice di essere un civile deportato, al che gli hanno chiesto di mostrare i documenti che attestassero quanto lui sosteneva; ma non aveva alcun documento. Allora hanno cominciato a picchiarlo menandogli botte da orbi. Quando ho visto così tiro fuori il mio tesserino di Italiano e, appena iniziano ad interrogarmi, quello che mi sembreva un colonnello comincia ad insultarmi dicendomi con fare sprezzante che appartenevo a quella razza di macaronì che li aveva fatti correre da Aix-la-Chapelle a Dunkerque e aveva mitragliato le donne francesi. Gli ho risposto: «Signor Colonnello, guardi che quando correvate da Aix-la-Chapelle a Dunkerque io ero a casa che giocavo al pallone, quindi si sbaglia ad accusarmi di questo.» Ma lui niente, continuava imperterrito ad inveire contro di me. Comunque non sono stato picchiato. Quando il colonnello si è calmato, ha ordinato: «Mandatelo nel corridoio con gli altri otto macaronì». Erano altri otto italiani che avevano fatto come me, aggregandosi ai Francesi per arrivare prima in Italia. Poi ci hanno sbattuti tutti in una cella di sicurezza. Una decina di giorni più tardi ci hanno caricato su un paio di gipponi e ci hanno portato a Lilla in un comando della polizia segreta francese, dove siamo stati sottoposti ad un interrogatorio. Io ho dichiarato di essere l’autista dell’Addetto Navale Italiano a Madrid e saltuariamente lo accompagnavo a Bordeaux dove c’era una nostra base di sommergibili atlantici; proprio lì, in occasione di una delle nostre trasferte, ci aveva sorpreso l’armistizio dell’Italia ed io, non avendo accettato di passare con i Tedeschi, ero stato fatto prigioniero e rinchiuso in campo di concentramento. L’ufficiale che m’interrogava rimase soddisfatto dal mio racconto e mi congedò dicendomi che presto sarei tornato a casa. Fummo nuovamente caricati tutti sui due gipponi e cominciammo a girare per i vari campi per rifugiati che si trovavano nei dintorni di Lilla alla ricerca di una sistemazione, ma erano tutti pieni; così ritornammo a Charleroi nella cella di sicurezza dalla quale eravamo partiti un paio di giorni prima e dove restammo fino alla capitolazione della Germania avvennuta il 7 maggio 1945. Un paio di giorni più tardi siamo stati portati in un campo di concentramento sulla Manica, del quale non ricordo il nome, dove siamo rimasti internati circa un mese. Un certo giorno arrivarono dei proprietari terrieri che cercavano mano d’opera per le loro aziende. Io mi offersi immediatamente dicendo che nella vita civile facevo il contadino e venni destinato, insieme ad un Genovese, ad un’azienda agricola di Saint-Laurent-Blangy, nei dintorni di Arras. Il nostro compito era di pulire le stalle del bestiame e rifornirle di foraggio tutte le mattine, poi di andare nei campi a lavorare. Lì venimmo a sapere che a Lilla viveva un certo conte Oneda che s’interessava degli Italiani reduci dai campi di concentramento tedeschi. Non ci pensammo due volte ad architettare la fuga in treno che avvenne per tutti e nove la domenica successiva, il nostro giorno libero. Giunti al cospetto del conte Oneda gli raccontammo le nostre vicissitudini che lui ascoltò con molta attenzione. Poi ci dette da mangiare e ci ospitò nella sua casa per trascorrervi la notte. Il giorno dopo ci portò al campo di prigionia dove ottenne il permesso per farci rimpatriare. Però, anziché farci il biglietto del treno per Nizza dove si trovava il Comitato di Liberazione Italiano, ce lo fecero solo fino a Marsiglia. Durante il viaggio convinsi gli altri di tentare la fortuna e di proseguire fino a Nizza dove giungemmo senza ulteriori intoppi. Per uscire dalla stazione passammo dal varco delle merci, suscitando le ire degli addetti alla loro movimentazione, perché se fossimo transitati dall’uscita passeggeri avremmo dovuto mostrare il biglietto valido solo fino a Marsiglia. Al Comitato di Liberazione Italiano fummo bene accolti. Ci procurarono delle stanze in un albergo e tornavamo lì per i pasti. Trascorse così un mese, che ricordo come un periodo spensierato durante il quale potei rilassarmi dopo tante traversie. Le giornate le trascorrevamo andando al mare o passeggiando per le vie di Nizza. Arrivò finalmente il giorno del rientro in Italia. Con un camion ci portarono al campo profughi di Bordighera dove restammo qualche giorno prima di essere trasferiti ai rispettivi comandi italiani per la discriminazione. Io, essendo un marinaio, dovetti presentarmi al Deposito Marina di Venezia, dove incontrai il 2° Capo Falasca del quale ho già parlato. Vi arrivai dopo un lungo viaggio in treno nell’Italia ancora devastata dalla guerra. Eravamo nell’agosto del 1945, ma dovetti aspettare fino al 2 settembre per riabbracciare i mie cari a Cherso. Con questo racconto si chiude la storia della mia avventura a BETASOM, che ha segnato una tappa importantissima della mia vita: ho conosciuto, e sono stato a stretto contatto, di persone di grandissima statura morale e professionale, primo fra tutti l’Ammiraglio Romolo Polacchini. Grazie al periodo trascorso alla Base si è stretto tra me e la Marina, ma soprattutto con i Sommergibilisti, un legame indissolubile che mi ha accompagnato per tutta la mia lunga vita. Il mio pensiero corre spesso alla Madonnina di BETASOM alla quale mi sono più volte appellato nei momenti più bui della mia prigionia e che sicuramente mi ha protetto consentendomi di portare a casa la pelle. Cari Comandanti, un grazie di cuore per avere apprezzato i miei ricordi degli anni vissuti a BETASOM e grazie per i lusinghieri commenti che avete ritenuto di rivolgermi dopo aver letto i miei numerosi racconti. Ringrazio infine l’amico Massimo che ha avuto la pazienza di ascoltarmi per ore traducendo le mie chiacchierate nelle testimonianze che ha postato sul Forum. Un saluto di cuore a tutti Voi! ¹ Il gasogeno era un combustibile “autarchico” che trovò ampia diffusione in tempo di guerra, penalizzando però sensibilmente le prestazioni del motore. Si trattava di una specie di caldaia verticale installata posteriormente alla vettura nella quale si bruciava legna o carbonella. I gas di combustione, composti da una miscela di monossido di carbonio, anidride carbonica, azoto e idrogeno, venivano pompati nel motore opportunamente modificato sostituendo la benzina. ² Il maquis era il movimento di resistenza e liberazione nazionale francese durante la seconda guerra mondiale. I combattenti partigiani erano detti maquisards. -
È trascorso da pochi giorni il 72° anniversario dell’8 settembre. Seguendo l’onda dei ricordi vorrei raccontare come vissi io quel fatidico giorno e i drammatici avvenimenti che seguirono. Devo fare una premessa. L’Ammiraglio Polacchini era stato trasferito in Italia il 28 dicembre 1942 e, dal gennaio 1943, fu destinato a Palermo come Comandante del Comando Marina. Mi aveva detto se volevo venire in Italia con lui… ma a Bordeaux c’era Edmonde, la mia ragazza. Gli risposi che sarei venuto volentieri se mi avesse potuto sistemare a Venezia o a Trieste, ma m’interruppe subito dicendomi: «Vedi Fucci, purtroppo non è possibile. Ci sono dei richiamati che hanno necessità di stare vicino alle famiglie e quindi non ti posso accontentare. Se vuoi venire in Italia in qualsiasi altro posto, non ci sono problemi». «No, no, la ringrazio Signor Ammiraglio – risposi - . Qui ho una ragazza e allora preferisco restare». Nuovo comandante superiore della base fu designato il Capitano di Vascello Enzo Grossi, già piuttosto chiacchierato all’epoca perché quando da Capitano di Corvetta comandava il sommergibile BARBARIGO sostenne di avere affondato due corazzate americane, ma forse non era vero. Quel giorno il Comandante Grossi non si trovava a Betasom. Improvvisamente i Tedeschi circondarono la Base (noi eravamo all’oscuro dell’avvenuta firma dell’armistizio), fecero prigionieri tutti gli uomini che vi si trovavano e piazzarono delle mitragliatrici per dissuaderci da ogni tentativo di fuga. Solo due o tre giorni dopo, al ritorno del Comandante Grossi, ci chiesero di fare una scelta: o passare con loro, o essere internati in campo di concentramento. Io pensai che avevo giurato fedeltà al Re, l’avevo scampata fino a quel momento e non me la sentivo di andare forse a morire per combattere al fianco dei Tedeschi, così scelsi di essere internato. D’altra parte vedevo che questa scelta l’avevano fatta anche degli ufficiali – ma non il Comandante Grossi – e dei carabinieri; così non ebbi dubbi sulla validità della mia decisione. Il campo in cui fui internato era a Pessac, nelle vicinanze dell’aeroporto di Merignac. Nel nostro campo, le baracche dei prigionieri erano costruite su palafitte per isolarle dal terreno che era costituito da sabbia umida; noi eravamo in cinque: io, un Secondo capo RT che si chiamava Nicola di cognome e Renato di nome, il Sergente RT Frandi Mario di Pisino, istriano anche lui; quel Paolo Muller che usciva con la sorella di Edmonde; infine c’era Puddu Renato, un sardo. Naturalmente c’erano molti altri prigionieri nella baracca, ma il nostro reparto era costituito da noi cinque. Allora, poichè eravamo a 6 o 7 metri dal reticolato, convinsi gli altri che avremmo potuto rompere il pavimento sotto le brande e fare un buco nel terreno per tentare la fuga; ogni giorno, col nostro piatto e il gavettino d’alluminio, scavavamo per approfondire questo buco e proseguire poi con una galleria. All’angolo della recinzione c’era una garitta con la sentinella: a turno, uno scavava e passava il gamellino con la sabbia all’altro che stava dietro; man mano che si procedeva, il numero dei componenti della “catena della sabbia” aumentava per arrivare a passare il gamellino a quello rimasto fuori, che provvedeva a stenderla sotto la baracca in modo che non si vedesse nessun cumulo. Ormai il tunnel aveva raggiunto una lunghezza di circa 5 metri e non collassava perché la sabbia bagnata del terreno lo teneva insieme. Ad un certo punto è intervenuto un fatto nuovo: un maresciallo dei nostri ha pagato un Polacco che aveva accettato di collaborare coi nazisti e, di notte, l’ha fatto scappare. La mattina successiva, all’appello, si sono accorti che mancava un prigioniero; allora i militari tedeschi hanno preso a girare per il campo con i cani e hanno trovato il nostro tunnel, così il piano di fuga è tramontato miseramente. Però a noi non ci hanno fatto niente perché non sono riusciti a scoprire chi aveva scavato la galleria. In realtà, se fossero stati furbi, ci avrebbero potuto trovare guardando la matricola riportata sui gamellini che avevamo lasciato nella galleria: quella volta ci era andata liscia! Mi è dispiaciuto leggere nel libro “Le avventure di un marinaio di BETASOM” scritto da Mario Frandi lo stesso racconto di cui sopra, ma con lo svolgimento dei fatti riguardanti lo scavo della galleria diverso da quanto avvenne in realtà e soprattutto l’essersi attribuito la paternità del tentativo di fuga, che invece fu solamente mia. Arriviamo al 28 settembre, una data che non dimenticherò mai, perché ci hanno caricato sui carri bestiame ammucchiati in più di duecento per ogni vagone con un bidone per fare i bisogni. Mi ricordo le porte scorrevoli dei carri, molto spesse e robuste perché dovevano trattenere il bestiame; non le hanno piombate, ma erano chiuse dall’esterno con un gancio, quindi era assolutamente impossibile fuggire. Dopo un’ora di attesa il treno è partito con due locomotive a carbone, una in testa e una in coda, perché altrimenti in salita una sola non sarebbe riuscita a trainare tutti quei vagoni. Non riuscivo a rassegnarmi all’idea di essere deportato in chissà quale posto della Germania e allora cercai d’inventarmi qualcosa per scappare; chiesi se qualcuno aveva con sé un coltellino col seghetto, o qualcosa del genere e venne fuori un coltello svizzero di quelli con diverse lame, tra le quali c’era anche un seghetto; ma il proprietario non me lo voleva dare, perché diceva che se fosse successo qualcosa avrebbe finito per andarci di mezzo lui; io lo rassicurai dicendogli che se ci avessero scoperto avremmo detto che eravamo stati noi cinque a tentare la fuga. Il mio piano era di riuscire a segare la porta del vagone per azionare il gancio esterno e, quando il treno avrebbe rallentato in salita, saremmo saltati giù. In realtà non ci eravamo resi conto del grande spessore di quella porta, per cui abbiamo cominciato a segare dandoci il cambio durante tutta la notte, ma alla mattina avevamo portato via solo un pezzetto della porta. A un certo punto arriva un militare e ci urla in tedesco: «Traditori di Badoglio, dove avete la sega?» In quel momento il coltellino l’avevo in mano io e gliel’ho consegnato; lui ha spezzato la lama della sega e l’ha gettata fuori, poi mi ha restituito il coltellino dicendo: «Per questa volta è andata così, ma alla prossima vi sparo». Alla fine siamo arrivati a Francoforte sul Meno; mentre siamo in stazione suona l’allarme aereo; i Tedeschi se la danno a gambe e ci lasciano dentro i vagoni chiusi dall’esterno, roba che se bombardano fanno una carneficina. Invece, fortunatamente, dopo una mezz’ora cessa l’allarme. I Tedeschi ci fanno scendere e da lì ci fanno camminare per circa 4 chilometri con lo zaino in spalla. Io avevo già regalato metà roba del mio corredo che, fra divise estive ed invernali, scarpe da libera uscita e da lavoro, era molto cospicuo. Arriviamo al campo dove saremmo stati internati; alla sera ci danno un po’ di brodaglia; non c’erano brande e dormivamo per terra sulla paglia; al mattino presto ci hanno fatto alzare e ci hanno preso tutta la roba che avevamo, i documenti, addirittura anche le mie patenti di guida; si sono tenuti i vestiti e con tutte le carte hanno fatto un falò nel piazzale. A quel punto non avevamo più identità, non eravamo identificabili se non per un numero che ci avevano assegnato. Ci hanno dato la divisa da prigionieri: sui pantaloni, all’altezza del ginocchio c’era la lettera M sulla gamba destra e la lettera I su quella sinistra, che stavano a significare “Militare Internato”, mentre sulla schiena del giaccone era riportata la scritta “Prigioniero di Guerra”. Sono stati davvero dei delinquenti perché i prigionieri di guerra ricevevano dei pacchi della Croce Rossa e noi niente, assolutamente niente perché eravamo internati e, quando è finita la guerra, non abbiamo ricevuto nessun indennizzo perché non avevamo lo status di prigionieri di guerra. Dopo qualche giorno ci trasferiscono in un campo nei pressi di Colonia, non mi ricordo il nome della località; so che era un po’ in collina. Alla mattina ci venivano a prendere con dei camion e ci portavano a lavorare a Colonia sulla ferrovia, oppure a sgombrare le macerie. Alcuni erano destinati nelle fabbriche. A noi cinque è toccato di andare a lavorare in uno stabilimento dove facevano le torrette per i sommergibili: come è strano il destino! A mezzogiorno ci davano una brodaglia con una patata o addirittura mezza, una carota; alla sera ci davano anche un pezzo di pane, che ci doveva bastare fino alla sera successiva. L’unico vantaggio era che lavoravamo al coperto, però tutti i giorni c’erano i bombardamenti. Ad un certo momento ci hanno portato in un campo più piccolo a margine del cantiere per la costruzione della fiera internazionale di Colonia, inattivo a causa della guerra. Lì eravamo in mezzo a dei Francesi internati che vestivano in borghese. Per uscire dal campo, dovevano passare davanti ad una baracca che aveva una finestra di vetro dietro alla quale c’era la guardia tedesca che avrebbe dovuto controllare se il Francese era autorizzato ad uscire; in realtà, siccome i Francesi erano gli unici a vestire in borghese, non veniva effettuato nessun controllo. Io ho subito pensato che questa leggerezza da parte delle guardie tedesche ci avrebbe forse consentito di scappare. Tutti noi cinque eravamo d’accordo per tentare la fuga. Però le cose stavano andando per le lunghe, per cui Mario Frandi, quello del libro, ha deciso di andarsene da solo; abbiamo poi saputo che è arrivato sano e salvo in Spagna; ha avuto una grande fortuna, perché i Tedeschi quando catturavano i fuggitivi, li maltrattavano e li mandavano a lavorare nelle miniere di sale. Arriva anche il giorno che scappa Puddu, ma lo prendono e non abbiamo saputo più niente di lui, solo che ha avuto una punizione terribile. Nonostante il rischio che sapevamo di correre, non ce la facevamo più a restare prigionieri in quel campo e allora io ho chiesto ai due amici che erano rimasti se fossero d’accordo nel tentare la fuga senza aspettare ancora. Loro si sono dichiarati d’accordo. Mi sono dato da fare per vendere l’orologio che ero riuscito a conservarmi e ho preso dei franchi francesi; Renato Nicola vende anche lui il suo orologio e prende dei marchi tedeschi; solo Muller è rimasto col suo orologio, ma non gliel’abbiamo fatto vendere, perché almeno uno di noi tre sarebbe stato in grado di sapere che ore erano. Io avevo salvato nel mio zaino un giaccone da marinaio e una paio di pantaloni della divisa, poi mi era rimasto anche il berretto con il nastro che riportava la scritta “SOMMERGIBILI”; in pratica avevo messo insieme una divisa da marinaio. Anche Renato aveva conservato la sua divisa da 2° Capo, ma gli avevo fatto strappare i bottoni dorati della Marina con l’ancora e gli avevo fatto cucire dei bottoni civili. Io invece ho scambiato con un Francese il mio giaccone militare con una giacca borghese, però sotto avevo la divisa. Il 28 di ottobre suona l’allarme aereo. Paolo Muller ci ha ripensato e ha rinunciato a scappare, forse perché non sapeva dove avrebbe potuto andare dopo: è vero che lui usciva con la sorella della mia ragazza, ma in famiglia non ne sapevano nulla; io invece ero fidanzato ufficialmente e a casa di Edmonde avrei trovato un rifugio sicuro. Allora io e Renato abbiamo trovato una valigetta 24 ore e ci abbiamo messo dentro i nostri berretti da marinaio, poi siamo usciti; c’era nebbia e siamo passati davanti alla baracca dove c’era il posto di controllo; il Tedesco, vedendoci in borghese, ci ha scambiati per Francesi e siamo transitati senza problemi. Paolo Muller ci ha lanciato al di là del reticolato la 24 ore e ci siamo incamminati verso la stazione ferroviaria di Colonia che non era molto lontana. Appena arrivati, vado a comprare con i soldi tedeschi che mi aveva dato Renato due biglietti per Francoforte sul Meno. Ci siamo seduti nella sala d’aspetto in attesa del treno, che era in ritardo; dopo un po’ vediamo passare all’esterno quelli col chiodo sull’elmetto, i militari della gendarmeria; ho pensato: non abbiamo documenti, se ci fermano e ce li chiedono siamo fritti; in effetti sono entrati, hanno guardato un po’ intorno e sono usciti dalla porta che dava sui binari; grande sospiro di sollievo da parte nostra. Finalmente arriva il treno e a quel punto mi sono un po’ confuso con il tedesco: ho domandato al capotreno che era sceso se quello era il treno proveniente da Monaco e lui, naturalmente in tedesco e in maniera sgarbata mi risponde: «Non viene, va a Monaco». Ho ringraziato e siamo saliti. Intanto si era messo a nevicare e faceva un freddo terribile. Nella valigetta 24 ore ho messo la giacca e abbiamo tirato fuori i nostri due berretti; Renato rovescia il cappotto e lo tiene sul braccio; in sostanza avevamo indosso solo la nostra divisa, da marinaio io e da sottufficiale Renato. Per essere più pronti a scappare non abbiamo preso posto in uno scompartimento, ma ci siamo seduti su un seggiolino ribaltabile nel corridoio. Viaggiavamo da un’ora e mezzo o due quando vediamo una luce che girava nel corridoio buio; fortunatamente non è arrivata fino a noi. Ho detto: «Questa volta ci è andata bene!». Proseguiamo un’altra oretta, perché ci voleva del tempo per andare da Colonia a Francoforte, quando veniamo illuminati dalla luce che prima non ci aveva inquadrato. Era il controllore, una donna anche abbastanza carina, che ci chiedeva i biglietti; io le ho detto che non capivo (ma avevo capito benissimo), poi le faccio: «Mussolini marine». E lei: «Gut kamerad! (…adesso proseguo in italiano). Non state lì nel corridoio a prender freddo, venite nello scompartimento; vi avviso io quando arriviamo a Francoforte». Siamo entrati in stazione più o meno alle 3 del mattino e faceva sempre più freddo; allora dico a Renato: non possiamo andare avanti così, tu non puoi mettere il cappotto, io non ce l’ho… Nella stazione c’era un Comando di tappa tedesco: un maresciallo con due militari controllavano i soldati che andavano in licenza o rientravano al corpo. Io vado dove sono i civili e il controllore delle Ferrovie che verificava la validità dei biglietti mi urla: «Dall’altra parte i militari». Io, con tono conciliante, rispondo: «È uguale… ». Poi mi rivolgo a Renato: «Muoviti cog###ne! Se ti fanno passare coi militari non hai nessun documento!» Allora passa anche lui e usciamo. Penso: «Adesso, con questo freddo, carichi di fame come siamo cosa facciamo?» Camminiamo attorno alla stazione e vediamo una grande sala d’aspetto piena di militari tedeschi. In un angolo c’era una specie di piccolo bar dove distribuivano una bevanda nera e amara, forse caffè d’orzo, non so cosa diavolo fosse, ma era calda. Ci sediamo ad un tavolo vuoto e dico a Renato: «Senti, io vado a prendere due tazze di quella roba lì. Quello che è, è, ma almeno ci scaldiamo un po’». Siamo lì da una mezz’oretta quando capita dentro la gendarmeria. Gli sussurro: «Svelto, facciamo finta di dormire». Avevamo una fifa tremenda: eravamo due mosche bianche, gli unici Italiani in mezzo a tutti quei militari tedeschi! Ma quelli sono passati senza notarci. Intanto ci eravamo informati a che ora c’era il treno per Metz, perché dovevamo andare verso la Francia. Bisognava aspettare fino alle 8.30-9 della mattina. Eravamo giunti all’ora in cui doveva arrivare il treno che proveniva da Amburgo, ma non si vedeva niente; poi siamo venuti a sapere che aveva più di due ore di ritardo. Noi non ce la facevamo più ad aspettare, allora mi rivolgo a Renato: «Senti, mi è venuta un’idea; ci stai? Adesso passiamo dal Comando di tappa tedesco e domandiamo dov’è la Feldkommandantur». [la Feldkommandantur era il Comando Militare della zona] E lui: «Va bene, tu sai un po’ parlare, io non so niente … quindi non ho alternative». Andiamo direttamente dal maresciallo e gli chiedo: «Per favore, sottufficiale mi sa dire dov’è la Feldkommandantur?» e lui, senza sospettare nulla: «Uscite dalla stazione, prima andate a destra, poi proseguite dritto finché non vedrete scritto, sulla sinistra, Feldkommandantur». Ho ringraziato, salutato e ce ne siamo andati. Fuori dal palazzo del Comando c’era una sentinella alla quale mi sono rivolto; ha suonato un campanello ed è uscito un Sergente. Gli dico: «Non parliamo tedesco». E lui: «Italiani?» «Sì – gli rispondo – cerco un ufficiale che parli l’italiano o il francese». «Sì, sì, c’è un Maggiore che parla bene il francese. Seguitemi». Ci accompagna su dal Maggiore, salutiamo e mi rivolgo a lui in tedesco: «Noi apparteniamo al Gruppo sommergibili di base a Bordeaux». Questo lo sapevo dire perché l’avevo imparato dal Comandante Anfossi. Gli spiego che non parlo fluentemente il tedesco e allora proseguirò in francese: «Noi siamo della Marina Italiana di Mussolini; veniamo dalla Scuola Sommergibilisti di Gotenafen [con il nome di Gotenhafen era stata battezzata la città polacca di Gdynia dopo l’invasione tedesca del 1939. Qui fu istituita una scuola di guerra per i sommergibilisti tedeschi. A partire dal 1941, a fianco dei Tedeschi operò anche la Sezione tattica sommergibili italiani (Marigammasom) dove veniva completato l’addestramento di ufficiali e marinai dei nostri sommergibili destinati a combattere in Atlantico] e il treno è partito con più di due ore di ritardo da Amburgo a causa di un bombardamento inglese sulla città. Mentre cercavamo di metterci in salvo, il sottufficiale – e indico Renato – ha rotto la tasca del cappotto e ha perso i documenti. Signor Maggiore, le chiediamo di farci i documenti per rientrare alla base di Bordeaux dove eravamo diretti e in più se ci fa dare qualcosa da mangiare, perché siamo a digiuno da due giorni». Lui chiama il sottufficiale e gli dice: «Faccia un permesso per questi due camerati italiani che sono di Mussolini e devono andare a Bordeaux; faccia anche un buono per tre giorni di mangiare». Questo compila i documenti, il Maggiore li firma e ci dice di andare al Comando di tappa della stazione dove avremmo potuto prelevare i viveri. Usciamo e andiamo verso la stazione ferroviaria: «Renato – dico – non fermiamoci qui a mangiare, prendiamo i treno e scendiamo a Metz, perché se gli è venuto qualche sospetto vengono a prenderci al Comando di tappa e ci fanno nuovamente prigionieri». Metz era la stazione successiva; scendiamo e andiamo al Comando tappa, dove troviamo un Sergente della Wehrmacht: «Buongiorno Sergente – dico mostrandogli il nostro permesso e il buono dei pasti per tre giorni – non abbiamo fatto in tempo a prelevare i viveri al Comando tappa di Francoforte perché il treno era in partenza, ci può far dare le nostre razioni?». Lui chiama un militare perché vada a prendere il mangiare; poco dopo ritorna con due pagnotte nere e una bianca, accompagnate da un quadrato di una sostanza indefinibile, probabilmente era margarina, ma la fame era così tanta che non abbiamo fatto gli schizzinosi. Risaliamo sullo stesso treno per Parigi e nello scompartimento troviamo dei militari teschi che andavano in Francia, chi a Parigi, chi altrove perché tutta la Francia era stata occupata. Abbiamo fatto combriccola; loro venivano da casa da dove avevano portato del lardo, del formaggio, del pane di segale e ci hanno invitato a condividere con loro ciò che avevano. Noi potevamo mettere in comune solo il pane e la margarina, ma era quello che loro mangiavano tutti i giorni e la nostra offerta non ha avuto molto successo. Fatto sta che abbiamo mangiato con loro e ci sembrava di aver fatto un grande pranzo. Alla sera eravamo già a Parigi. Io tiro fuori i soldi francesi e andiamo in un alberghetto nelle vicinanze della stazione; dopo essermi informato quando partiva il primo treno per Bordeaux e saputo che ci sarebbe stato solo la mattina successiva verso le 8.15, abbiamo preso una stanza. Non ci pareva vero di passare finalmente una notte in un letto e ci siamo buttati a dormire vestiti, tanta era la stanchezza e il sonno arretrato. Ci siamo svegliati la mattina dopo, solo pochi minuti prima dell’orario di partenza del treno e siamo corsi di volata in stazione senza nemmeno lavarci, fortunatamente eravamo già vestiti! Il treno era in partenza, carico di militari. Un ufficiale ci ferma mentre stiamo salendo dicendoci che quel convoglio è riservato alle truppe tedesche. Allora io gli faccio: «Mussolini Marine, andiamo a Bordeaux…» In sostanza gli dico che noi dobbiamo assolutamente rientrare alla base di Bordeaux e lui: «Ja, ja kamerad, gut, gut, gut». Stavamo viaggiando già da un po’ di tempo quando arriva il controllore francese al quale domando se alla stazione di Bordeaux c’è un Comando tappa della Marina italiana. Lui mi risponde affermativamente assicurandomi che è aperto tutti i giorni; quindi, appena il treno si ferma in stazione, scendiamo e cerchiamo di squagliarcela senza farci notare, perché se quelli del Comando di tappa ci avessero individuato, saremmo finiti nuovamente alla Base. Ma eravamo in divisa, io la giacca borghese l’avevo messa dentro la valigetta e Renato continuava a portare il cappotto rovesciato sul braccio. Il Sergente di servizio al Comando di tappa ci ha notato e fermato, chiedendoci di mostrargli i permessi. Naturalmente noi non avevamo alcun permesso all’infuori di quello tedesco e allora, strizzandogli l’occhio, gli ho detto: «Ma va là, che abbiamo fatto una scappata per venire a trovare due ragazze che conosciamo». E lui di rimando: «Sapete che questo non si può fare; adesso io dovrei denunciarvi». «Dai, non farlo…». A questo punto lui m’interrompe: «Ma io ti conosco. Non eri imbarcato sul MOROSINI?» Evidentemente mi confondeva con un altro, ma prendo la palla al balzo: «Lo vedi che mi conosci?» «Va bè, va bè, per questa volta andate». Siamo usciti dalla stazione e lì io e Renato ci siamo lasciati con un abbraccio; non ho saputo più niente di lui. Come ho già detto in un altro dei miei racconti, sono subito andato a casa di Edmonde, creando una grande sorpresa in tutta la famiglia perché non avevano più avuto mie notizie da quando ci avevano portato via dal campo di Pessac, tre settimane prima. La loro accoglienza fu la stessa che avrebbero riservato ad un figlio. Purtroppo il mio rifugio presso la famiglia di Edmonde fu di breve durata, perché durante un mio spostamento in bicicletta dal locale dove stavo rintanato nella fabbrica di botti di suo padre per andare alla villa di Pessac, venni riconosciuto da due miei ex commilitoni di Betasom che erano passati con i Tedeschi, il Sergente autista Annibale Riva e il 2° Capo Falasca che mi fecero arrestare dai Tedeschi. A proposito del 2° Capo Falasca, mentre ero al Deposito Marina di Venezia appena rientrato in Italia nell’agosto del 1945, per essere sottoposto alla discriminazione [La “discriminazione” era una sorta di interrogatorio cui erano sottoposti gli internati militari italiani reduci dalla Germania per stabilire se dopo l’8 settembre erano passati a collaborare con i Tedeschi. Venivano quindi sbrigate la pratiche amministrative e matricolari dei reduci, penalizzando coloro che venivano identificati come collaborazionisti], l’ho incontrato e lui mi si è avvicinato per chiedermi di ritirare la denuncia che avevo fatto nei suoi confronti per avermi arrestato insieme al Sergente Riva. Per lui sarebbe stato importante, perché, essendo di carriera, con questa mia denuncia che testimoniava la sua collaborazione con i Tedeschi, sarebbe stato congedato. Mi è venuto in mente tutto il male che mi aveva fatto arrestandomi e allora non ci ho visto più: gli ho urlato di andarsene via e di non farsi vedere mai più, perché assieme agli altri marinai rientrati dalla prigionia che avevano assistito a questo nostro alterco, avrei potuto fargli passare un brutto momento. Torniamo al mio nuovo internamento. Arrivato in Germania, sono stato portato in una caserma delle SS nei pressi di Stoccarda, dove ho dovuto difendermi dall’accusa di diffamazione nei confronti dei Tedeschi. Ho detto solamente che ero molto arrabbiato per il trattamento che avevo ricevuto durante la prigionia, ma non li avevo mai diffamati. Per mia fortuna lì ho trovato un Maggiore, una brava persona, che si era quasi commosso a sentirmi raccontare le mie vicende vissute da prigioniero. Comunque, se avessero voluto delle maggiori informazioni sul mio conto, avrebbero potuto rivolgersi al Capitano di Fregata Becker della Kriegsmarine, il quale era stato ufficiale di collegamento tedesco a Betasom e mi aveva conosciuto personalmente quando svolgevo la mia mansione di autista alla Base. Dopo questa mia dichiarazione, l’interrogatorio è terminato e mi hanno portato in un campo di concentramento vicino a Monaco di Baviera, a Ludwigsburg. Lì, lavorando, mi era venuto un ascesso a un dito della mano; mi hanno portato all’ospedale per prigionieri di Hellbrun, dove mi hanno operato senza alcuna anestesia e ho dovuto sopportare un dolore indescrivibile. Poco tempo dopo, sono stato trasferito a Papenburg, vicino a Dortmund in un piccolo campo di concentramento. Lì divento amico di un Olandese che lavorava nella ditta Johan Bunte di Papenburg. Noi internati lavoravamo fuori dal campo, però non ci portavano con i camion perché eravamo sparpagliati in diverse fabbriche. Nel mio caso, mi veniva a prendere questo Olandese che mi portava a lavorare nella stessa ditta dove lavorava lui. C’erano dei camion, dei pullman… ma adesso comincia un’altra storia.
-

Chersino Racconta: Il Mio Incontro Con Bruno Mussolini
una discussione ha aggiunto Chersino in Gli Uomini
Nell’aprile 1941, Bruno Mussolini – allora capitano pilota della Regia Aeronautica – era andato a Desvres, nei pressi del Passo di Calais, per ispezionare gli aerei del Corpo Aereo Italiano che vi erano dislocati in supporto alla Luftwaffe per operazioni di bombardamento sull’Inghilterra. Probabilmente la sua missione era stata voluta dal Duce, visti gli scarsi risultati ottenuti – si diceva a causa di problemi tecnici che i nostri aerei incontravano – tanto che pochi giorni dopo tutti gli aerei del CAI rientrarono in Italia. Durante il viaggio di ritorno, Bruno Mussolini espresse il desiderio di visitare la base di Betasom. Col suo aereo atterrò all’aeroporto di Mérignac ed io accompagnai l’ammiraglio Parona e il suo aiutante di bandiera comandante Anfossi a riceverlo. Rimasi colpito da questo giovane aitante, di bella presenza, molto sicuro di sé, di buona parlantina (anche se non mi rivolse mai la parola), che dimostrava grande interesse a tutte le attrezzature della Base. L’ammiraglio Parona gli fece anche visitare un sommergibile che in quel momento si trovava nel bacino a livello costante. Restai molto stupito nel constatare che il figlio del Duce dava del tu all’ammiraglio, mentre lui gli dava del lei. Il giorno successivo riaccompagnai, con la Fiat 1500 Viotti in dotazione all’ammiraglio, tutti e tre all’aeroporto di Mérignac ed assistetti al decollo dell’aereo di Bruno Mussolini. Pochi mesi più tardi, ai primi di agosto, il figlio del Duce morì vicino a Pisa durante il collaudo di un nuovo modello di bombardiere. -

Il Capo Ghezzi E' Salpato Per L'ultima Missione
Discussione ha risposto a Chersino in una lazer_one nella sezione Quadrato Ufficiali
Ciao caro Amico e commilitone. Quanta tristezza nell'apprendere della Tua scomparsa! Ripenso a quando ti ho conosciuto solo 9 mesi fa al raduno di La Spezia e alla lunga chiacchierata che ci siamo fatti ... poi in prima fila, uno di fianco all'altro, ad assistere alla presentazione del Pietro Venuti. E il pranzo al Circolo Ufficiali seduti allo stesso tavolo. Ora è tutto finito! Onori a Te, Capo Ghezzi. -

Forza Capo Ghezzi
Discussione ha risposto a Chersino in una Totiano nella sezione Quadrato Ufficiali
Forza capo Ghezzi!!! Io e te siamo tra le pochissime voci storiche rimaste della nostra gloriosa Base. Non ci abbandonare! Ti faccio tanti auguri perchè tu torni presto ad essere dei nostri. -

Chersino Racconta: Un Grande Amore Sbocciato A Bordeaux
una discussione ha aggiunto Chersino in Gli Uomini
Erano i primi mesi del 1942. Nel tardo pomeriggio di una fredda giornata invernale stavo accompagnando l’ammiraglio Polacchini ed il suo aiutante di bandiera comandante Anfossi allo Château du Mulin d’Ornon. Lungo la strada che percorrevo normalmente per andare dalla Base a Gradignan, ancora nella città di Bordeaux, giunti davanti ad uno spaccio di tabacchi, l’ammiraglio mi dice: «Fucci, fermati un momento. Mi vai a prendere una scatola di fiammiferi?» Accosto la macchina al marciapiede, entro e vedo una ragazza bellissima dietro al banco; le dico: «Mademoiselle, s’il vous plaît une boîte d’allumettes». Lei si mette a ridere, evidentemente per la mia pronuncia, poi mi dà la scatola di fiammiferi. Ci salutiamo e io fra me e me mi sono detto: «Adesso te non mi scappi più». Da quel giorno, tutte le volte che passavo da solo davanti allo spaccio entravo a salutarla e lei mi ricambiava con un bel sorriso. Erano due sorelle, Edmonde (la ragazza che mi aveva colpito per la sua bellezza) e Andrée. La mamma non le lasciava mai uscire sole; anche quando andavano a prelevare i tabacchi erano insieme. Insomma, alla fine avevo attaccato bene con Edmonde e una volta entro nello spaccio e le dico: «Senti, per l’appuntamento sai come facciamo? Io vengo a prendere una scatola di fiammiferi e tu mi dici l’orario che vieni fuori, così io ti apetto». Ma la mamma, una specie di cerbero, non mi vedeva di buon occhio e le diceva: «Ce qu’il fait ici ce macaroni?». I Francesi, in senso dispregiativo, ci chiamavamo “macaronì”. Siccome era furba, aveva capito che saremmo usciti insieme e allora all’appuntamento Edmonde si è presentata accompagnata da Andrée che non ci lasciava mai soli neppure per un momento. Dopo un po’ di volte ne avevo piene le scatole della sorella e allora ho pensato che avrei dovuto trovare qualcuno della Base che si mettesse con lei. Così mi sono rivolto ad un sergente radiotelegrafista di Firenze, un certo Paolo Muller. Gli dico: «Paolo, ti vorrei presentare una bella ragazza, ma non una ragazza di strada, una di buona famiglia…» e lui è venuto a conoscerla. Quel pomeriggio, quando stavamo per lasciarci al termine di una lunga passeggiata, ho chiesto ad Andrée: «Alors, comment ça va?» E lei di rimando: «Tres bien, tres bien!». Avevo finalmente risolto il mio problema! Quando uscivamo, ci davamo un appuntamento per l’ora del rientro. Poi loro andavano da una parte, noi dall’altra e tornavamo tutti insieme a casa delle ragazze. Con il tempo ero riuscito a conquistare anche la madre: aveva capito che avevo intenzioni serie e allora non era più così ostile nei miei confronti. Anzi, spesso mi invitava a mangiare a casa loro. Erano persone che stavano molto bene: il padre aveva una fabbrica di botti in rovere per l’invecchiamento dei famosi vini di Bordeaux che dava lavoro a una trentina di operai. Abitavano in una bella casa nel centro della città e avevano anche una villa in campagna a Pessac, dove mi invitavano la domenica quando ero libero dal servizio; avevano anche una villa al mare ad Arcachon, ma ci andavano poche volte solo d’estate. Naturalmente anche a Pessac ci appiccicavano sempre dietro Andrée, ma lì non c’era l’amico Muller a farsi carico del terzo incomodo e allora dovevamo limitarci a passeggiare mano nella mano. Una foto nel giardino della villa di Pessac Ma proprio a Pessac, in antitesi ai bei momenti trascorsi in compagnia di Edmonde, ebbe inizio il mio calvario di prigioniero conseguente alla mia scelta di non collaborare con i Tedeschi dopo l’8 settembre. Infatti fui internato in un campo nelle vicinanze dell’aeroporto di Merignac. Edmonde veniva tutti i giorni a portarmi il mangiare, evitandomi così di dovermi nutrire con la sbobba che passavano i Tedeschi. Però questo non era consentito dal regolamento e allora il comando del campo chiamò i vigili di Pessac e la fece arrestare. Così Edmonde fu confinata in una “casa d’attesa”, ma non le fu torto un capello; doveva semplicemente condividere le sue giornate con le altre donne che vi erano rinchiuse. L’hanno trattenuta qualche giorno, poi, quando hanno capito chi era, l’hanno lasciata andare a casa. Il 20 ottobre del 1943 mi presentai nuovamente a casa di Edmonde: ero scappato dal campo di concentramento in Germania dove ero stato trasferito dopo pochi giorni di permanenza in quello di Pessac. Appena mi hanno visto, denutrito e infestato di pidocchi, sono rimasti tutti esterrefatti. Mi hanno accolto come un figlio, dandomi ospitalità e rivestendomi da capo a piedi con abiti nuovi, probabilmente del padre di Emonde. Ho passato il Natale con loro. Sopra lo spaccio tabacchi avevano due camere. In una dormiva Edmonde e nell’altra Andrée; allora i genitori hanno mandato Edmonde a dormire con la sorella e io mi sono sistemato nella sua camera. Però continuavo a far vita da prigioniero, seppure in condizioni totalmente diverse da quelle del campo di concentramento. Infatti Edmonde mi portava da mangiare a mezzogiorno e alla sera, ma non potevo uscire; unico conforto era la sua compagnia: ci volevamo molto bene, ma il nostro era un amore platonico perché, a causa del pavimento di legno, nello spaccio sottostante si sentiva ogni nostro movimento. Ogni tanto, uscendo dalla tabaccheria con mille precauzioni, andavo a passare qualche giorno nella villa dei genitori di Edmonde a Pessac e questo era l’unico diversivo che mi era concesso, sul quale fantasticavo per giorni interi nella solitudine in cui ero costretto a vivere. Poi, un certo giorno, mi sono consigliato con il papà di Edmonde, che era molto preoccupato per questo andirivieni di marinai italiani che erano passati con i Tedeschi e venivano lì a comprare le sigarette o a bere qualcosa, attirati anche dal fatto che dietro al banco c’erano due belle ragazze; ed io stavo nascosto di sopra. Se fossi stato scoperto , non solo io avrei passato un guaio, ma tutta la famiglia. Convenimmo allora che sarebbe stato meglio se mi fossi spostato nella fabbrica di botti, che al momento era chiusa. Sopra la falegnameria c’era un bellissimo ufficio, che fu riadattato per ospitarmi. C’era il mio letto, in un piccolo locale c’era il bagno con il lavandino, la doccia e il water. Insomma, in quello che era l’ufficio del papà avevano ricavato un bel mini appartamento. Bisogna dire che i Francesi erano un bel po’ avanti rispetto a noi e avevano delle comodità che da noi sarebbero arrivate solo dopo la guerra. Io, approfittando del buio che già dal pomeriggio di quelle giornate invernali regnava su Bordeaux oscurata, mi spostavo in bicicletta dalla fabbrica alla casa di Edmonde ; lei tutti i giorni veniva, sempre in in bicicletta, a portarmi il pranzo, poi restava lì con me per qualche ora e abbiamo vissuto dei bellissimi momenti d’intimità. Ma come tutte le cose belle, questa parentesi fu di breve durata, perché un giorno, mentre stavo andando alla villa di Pessac, fui notato senza che me ne accorgessi da due miei ex commilitoni passati coi Tedeschi (uno era il sergente autista Annibale Riva, al quale avevo fatto anche del bene quando facevo l’autista del comandante superiore e l’altro era l’Aiutante del Campeggio marinai, 2° capo Falasca che avrei poi ritrovato a Venezia, dopo essere stato rimpatriato, a passare con me la discriminazione, ma questo fa parte di un’altra storia) i quali mi pedinarono fino alla casa di Edmonde e due giorni dopo arrivarono con un manipolo di Tedeschi per arrestarmi. Fu quella l’ultima volta che vidi Edmonde. Mi riportarono a Bordeaux e fui rinchiuso in una cella di sicurezza; passato qualche giorno venni rispedito in Germania su un carro bestiame e ripresi la mia vita di prigioniero in un campo di concentramento. Quando ritornai a Cherso dopo la lunga odissea della mia prigionia, cercai in tutti i modi di mettermi in contatto con Edmonde, ma purtroppo senza alcun risultato. Mi resta di lei solo un meraviglioso ricordo che ha rappresentato una luce di speranza negli anni bui della prigionia, aiutandomi a superare umiliazioni, pericoli e privazioni che caratterizzarono la mia vita in quel triste periodo. Già, solo un dolce ricordo, perché le rare fotografie di Edmonde che ero riuscito a salvare dalle grinfie dei Tedeschi nei campi di concentramento andarono distrutte quando i titini incendiarono la mia casa a seguito della mia decisione di mantenere la nazionalità italiana. -

Chersino Racconta: Non Sempre Rose E Fiori Al Servizio Del Comandante Grossi
Discussione ha risposto a Chersino in una Chersino nella sezione Gli Uomini
Ti ringrazio dei complimenti per i miei racconti che Massimo ha la pazienza di ascoltare e di mettere per iscritto sul Forum. Da buon Istriano non potevo non avere nella mia biblioteca Le Maldobrìe (in Italiano "scherzo", "birichinata") e, sempre degli stessi autori Carpinteri e Faraguna, Prima della prima guerra, L'Austria era un paese ordinato, Noi delle vecchie province, Povero nostro Franz, Vival'A. -

Chersino Racconta: Non Sempre Rose E Fiori Al Servizio Del Comandante Grossi
Discussione ha risposto a Chersino in una Chersino nella sezione Gli Uomini
Ti ringrazio per il commento che hai postato in calce al mio racconto. Non ho letto il libro di Frandi, pur sapendo della sua esistenza, perché non sono mai riuscito a venirne in possesso; sarebbe bello se si riuscisse a pubblicarlo in digitale sulla Biblioteca di Betasom. Invece mi ricordo molto bene di Mario, mio conterraneo perché è (o era?) di Pisino, un paese proprio al centro dell’Istria; Cherso si trova poche miglia a Sud-Est ed è la più settentrionale delle isole istriane. Frandi era un sergente RT e, dopo l’8 settembre, fu internato anche lui nel campo di Pessac, vicino a Bordeaux. Eravamo in cinque nella stesso scomparto della baracca e noi due eravamo gli unici istriani, quindi eravamo ancor più affratellati avendo la stessa origine. Tentammo la fuga, purtroppo fallita, e in seguito affrontammo insieme diverse traversie, a partire dalla fatidica data del 28 settembre quando ci caricarono su un carro bestiame per essere trasferiti in Germania. Fummo destinati ad un campo nei pressi di Francoforte sul Meno. Qualche giorno dopo ci trasferirono in un campo vicino a Colonia. Tutti noi cinque che eravamo rimasti uniti da quando ci eravamo trovati nel campo di Pessac avevamo un’idea fissa: tentare la fuga. Però Frandi non ebbe la pazienza di attendere il momento giusto per scappare e decise di andarsene da solo. Molto tempo dopo venni a sapere che era riuscito ad arrivare incolume in Spagna, ma da quella volta non ho più avuto sue notizie. Questo, per sommi capi, il periodo della prigionia che ho trascorso insieme a Mario Frandi, ma spero di riuscire a raccontare prossimamente tutta la vicenda in maniera più dettagliata. Ho notato, rivedendo il racconto postato ieri, che è sparita la foto della macchina del comandante della base con me al volante. Provo ad inserirla nuovamente. -

Chersino Racconta: Non Sempre Rose E Fiori Al Servizio Del Comandante Grossi
una discussione ha aggiunto Chersino in Gli Uomini
Come ho già detto in passato, sono arrivato a BETASOM con il Malaspina il 4 settembre 1940, una data che resterà per sempre indelebile nella mia mente, e pochi giorni più tardi per uno strano caso del destino (il Malaspina affonderà con tutto il suo equipaggio in circostanze sconosciute un anno più tardi alla sua sesta missione) fui sbarcato e divenni l’autista del Comandante superiore della Base ammiraglio Parona, insediatosi qualche settimana prima in quella posizione. Non ho ricordi di particolare rilievo del periodo passato al servizio dell’ammiraglio Parona: era una persona molto discreta, di poche parole e spesso impegnato in incontri con il Comandante della flotta sottomarina tedesca ammiraglio Dönitz, che era di stanza a Parigi, il quale veniva abbastanza sovente a BETASOM intrattenendosi in lunghi colloqui riservati con l’ammiraglio Parona. Fu proprio in occasione di uno di questi incontri, mentre stavo accompagnando l’ammiraglio Parona e il Comandante Aldo Cocchia – allora Capo di stato maggiore della Base – all’aeroporto di Mérignac per ricevere Dönitz, che sentii Parona lamentarsi con Cocchia per come il capo dei sommergibili teschi tenesse in poca considerazione l’alleato italiano. Secondo lui i comandanti e gli ufficiali erano scarsamente preparati per affrontare la battaglia dell’Atlantico, gli equipaggi erano formati da “marinai raccogliticci che non avevano nessuna esperienza di sommergibili”, i nostri battelli erano inadeguati per le loro grandi dimensioni e la scarsa manovrabilità ad infilarsi in mezzo ai convogli nemici. Nessun riferimento ai tanti episodi di eroismo e di lealtà verso l’alleato tedesco in cui fin dalle prime missioni i nostri equipaggi si erano contraddistinti. Evidentemente, quando ci fu chiesto di mandare quattro nostri sommergibili a recuperare i naufraghi dell’Atlantis l’ammiraglio Dönitz aveva cambiato parere su di noi e sui nostri battelli … Questa fu una delle poche confidenze che ebbi modo di cogliere dall’ammiraglio Parona. D’altra parte io ero totalmente inesperto di come funzionassero le cose a BETASOM, quindi me ne stavo molto sulle mie, attento a svolgere nel modo migliore il compito cui ero stato destinato. Nel settembre del 1941 il CV Romolo Polacchini – già presente BETASOM dal mese di aprile dello stesso anno come Capo di Stato Maggiore – promosso contrammiraglio a soli 44 anni sostituì l’ammiraglio Parona rientrato in Italia. L’ammiraglio Polacchini aveva un carattere completamente diverso da quello del suo predecessore e mi aveva preso molto presto a benvolere, dandomi consigli pratici su come muovermi a Bordeaux quando andavo in libera uscita come avrebbe fatto un padre col proprio figlio. In breve tempo conquistai la sua fiducia e mi affidò anche incarichi molto delicati che svolsi sempre con la massima dedizione, sentendomi onorato di come lui mi valutava. Tutto questo durò fino agli ultimi giorni di dicembre del 1942, quando il CV Enzo Grossi fu nominato Comandante Superiore della Base. Peraltro l’ammiraglio Polacchini non credo che nutrisse una grossa stima per Grossi e di ciò ne ebbi conferma un giorno che accompagnai in macchina lui e il Comandante Gianfranco Gazzana Priaroggia alla Base in occasione della partenza per una nuova missione del sommergibile Leonardo da Vinci. Dai discorsi che facevano i due, seduti sul divano posteriore, capii che l’ammiraglio esprimeva seri dubbi sulla veridicità dell’avvenuto affondamento delle due corazzate americane da parte del Barbarigo comandato da Grossi. Naturalmente non rivelai mai a nessuno quanto avevo orecchiato da quella conversazione, perché la riservatezza era indispensabile per il delicato incarico che ero chiamato a svolgere. Quando Grossi era ancora al comando del Barbarigo, era l’unico comandante di sommergibili autorizzato a vivere con la famiglia in una villetta che mi pare si trovasse nei pressi del Château de Raba. Mi aveva colpito uno strano rituale che la moglie svolgeva ogni volta che lui partiva in missione: spargeva nel giardino della loro abitazione dei sassolini e delle briciole di pane. Incuriosito, chiesi all’ammiraglio Polacchini il motivo di quei ripetuti bizzarri episodi e lui mi rispose che la signora era ebrea e quella era una loro tradizione portafortuna, ma la cosa mi lasciò piuttosto interdetto. Proprio la signora Grossi fu la protagonista di un fatto che mi ferì profondamente. Una volta, lui era già diventato il Comandante della base, ho accompagnato la signora ad un ricevimento organizzato dal Consolato italiano al quale era stata invitata. Appena arrivati, scendo, le apro la portiera e lei mi domanda: «Andrea, per caso hai uno straccio qui in macchina?» «Forse sì», ho risposto. Sono andato a cercare lo straccio e con questo nelle mani mi ripresento alla signora per sapere cosa ne doveva fare e lei: «Puliscimi le scarpe». In quel momento mi sono sentito veramente umiliato: vestivo una divisa di cui andavo fiero, mi trovavo davanti alla sede di rappresentanza della mia patria con la barriera italiana che garriva al vento sopra le nostre teste. Allora non ci ho più visto e le ho risposto: «Guardi signora, che io sono qui per fare l’autista del Comandante e non per pulire le scarpe a lei.» Mi sono girato e sono andato a rimettere lo straccio nel baule, mentre lei mi minacciava dicendo che mi avrebbe fatto trasferire in Africa. Non credo che abbia riferito quel fatto increscioso al marito, perché lui non me ne ha mai parlato. Per la verità anche il Comandante Grossi non ha mai mostrato molto rispetto nei miei riguardi. Le racconto un episodio su tutti. Nei primi mesi del ’43 l’ho accompagnato in missione a Biarritz per compiti d’ufficio. Avrebbe dovuto essere di ritorno a Bordeaux attorno alle quattro del pomeriggio per degli impegni che aveva preso precedentemente. Senonchè lungo la strada del rientro la macchina ha cominciato a manifestare dei problemi di alimentazione di benzina: procedeva a singhiozzo e poi si fermava. Ogni volta scendevo, spurgavo l’aria dal carburatore e ripartivo e questo si è ripetuto più volte. Grossi era molto spazientito, quasi che il problema che si era manifestato fosse dipeso da me. Arriviamo a Dax e Grossi mi ordina di andare al Comando tedesco. Lì si è fatto dare una macchina che l’ha accompagnato a Bordeaux, lasciandomi in mezzo alla strada senza dirmi nulla. A forza di strappi e soste forzate sono arrivato e Bordeaux dove l’auto è stata riparata nell’officina della base. Nei giorni successivi, il Comandante Grossi non ha mai fatto cenno all’episodio di Dax e sono convinto che non mi abbia mai considerato una persona, ma solamente una cosa necessaria allo svolgimento della sua attività. La FIAT 1500 carrozzata Viotti auto di rappresentanza del Comandante superiore di BETASOM Un fatto emblematico può raffigurare meglio il suo carattere. Il 26 luglio 1943, all’indomani della comunicazione dell’avvenuta deposizione di Mussolini e dell’assunzione dell’incarico di capo del Governo da parte del maresciallo Pietro Badoglio, tutte le foto, i quadri e le statuine del Duce che ornavano il suo studio erano sparite. Rimaneva soltanto la fotografia ufficiale del Re appesa a una parete. Peraltro il comandante Grossi che, a parte il suo comportamento dopo la deposizione di Mussolini che aveva tutta l’aria di un voltafaccia, si dichiarava un fascista convinto. L’8 settembre 1943 i tedeschi occuparono la Base e fecero prigionieri tutti i militari e civili italiani che erano presenti, tenendoli segregati nella base in attesa del rientro a BETASOM del comandante Grossi, assente in quel momento. Trascorsero due o tre giorni e solo allora ci fu chiesto di fare una scelta: o passare con loro, o essere internati in campo di concentramento. Io ho pensato che avevo giurato fedeltà al Re, l’avevo scampata fino a quel momento e non me la sentivo di andare a combattere e forse a morire al fianco dei Tedeschi. Così scelsi di essere internato. D’altra parte vedevo che questa scelta l’avevano fatta in molti, anche degli ufficiali – ma non il comandante Grossi – e dei carabinieri ed allora non ebbi dubbi sulla validità della mia decisione. Mi aspettavano tre lunghi anni di prigionia trascorsi in diversi campi di concentramento in Germania e in Francia, dei tentativi di fuga – uno anche riuscito – ed infine il ritorno a casa. È una storia lunga, che mi costa molta fatica ricordare per le sofferenze che ho dovuto sopportare, ma credo di avere il dovere di metterla un giorno a disposizione del nostro Forum perché anche i più giovani conoscano i travagli della prigionia che tanti militari italiani che, come me, non avevano fatto altro che il proprio dovere, dovettero subire nelle mani dei nostri ex alleati. -

Chersino Racconta: Il Recupero Dei Naufraghi Dell'atlantis
una discussione ha aggiunto Chersino in Gli Uomini
Un’altra storia interessante da raccontare è quella dell’intervento dei nostri sommergibili per trarre in salvo gli uomini dell’Atlantis, la nave corsara tedesca famosa per il gran numero di navi colate a picco nella sua unica lunghissima missione. L'Atlantis in uno dei suoi tanti camuffamenti Verso la fine di novembre del 1941 l’Atlantis fu affondata nell’Atlantico meridionale dall’incrociatore inglese Devonshire, mentre stava rifornendo un sommergibile tedesco che si immerse immediatamente per sfuggire al fuoco dell’incrociatore. L’equipaggio dell’Atlantis e i numerosi prigionieri che vi si trovavano a bordo presero posto sulle scialuppe e sulle zattere di salvataggio che furono prese a rimorchio dal sommergibile tedesco riemerso dopo che il Devonshire aveva lasciato la zona dell’affondamento senza soccorrere i naufraghi nel timore di essere attaccato dal sommergibile. Il convoglio così formatosi fece rotta verso il Brasile, dove il comandante dell’Atlantis Rogge aveva deciso di farsi rimorchiare essendo quello un paese neutrale. Qualche giorni dopo i naufraghi furono avvistati dalla nave appoggio sommergibili tedesca Python che li prese a bordo senza per questo interrompere la sua missione. Il 1° dicembre il Python venne intercettato da un altro incrociatore inglese (che poi si seppe essere il Dorsetshire, della stessa classe di quello che aveva affondato l’Atlantis) mentre stava rifornendo due U-Boot a sud dell’isola di Sant’Elena. In breve tempo il Python venne affondato a cannonate e i naufraghi dell’Atlantis, assieme a quelli del Python, furono costretti ancora una volta ad imbarcarsi sulle scialuppe e sulle zattere che il comandante Rogge aveva avuto l’accortezza di fare imbarcare sul Python quando questo li aveva soccorsi. I due sommergibili tedeschi che si stavano rifornendo dal Python, più altri due fatti convergere sul posto dal Comando Sommergibili tedesco imbarcarono tutti i naufraghi delle due navi, circa 400 uomini e fecero rotta verso nord diretti alle basi tedesche in Francia. Fu subito evidente che le condizioni di vita a bordo dei sommergibili tedeschi così sovraffollati erano pressoché impossibili ed allora entrarono in gioco i nostri battelli. In quel periodo, noi eravamo rimasti con 11 sommergibili dislocati a BETASOM; gli altri erano stati per la maggior parte affondati, salvo 10 che erano rientrati in Italia. In un primo tempo i Tedeschi ci deridevano perché avevamo questi grandi sommergibili che loro consideravano poco adatti per la guerra ai convogli. Infatti gli U-Boot erano molto più piccoli. Tant’è vero che su consiglio (… o disposizione) di Dönitz le torrette furono rimpicciolite e modificate internamente. Infatti in origine esse contenevano addirittura la cucina. Però i Tedeschi cambiarono velocemente opinione sulle dimensioni dei nostri sommergibili quando Dönitz chiese all’ammiraglio Polacchini di inviare i quattro sommergibili più grandi che si trovavano alla Base a recuperare i naufraghi dell’Atlantis e del Python. La battaglia dell’Atlantico era in una fase culminante perché dagli Stati Uniti partivano sempre più numerosi i convogli diretti in Inghilterra, quindi Dönitz non voleva distrarre altri sommergibili dalla caccia ai convogli. In quel momento erano ormeggiati a BETASOM il Finzi, il Tazzoli, il Torelli e il Calvi, rispettivamente al comando del CC Ugo Giudice, CC Carlo Fecia di Cossato, CC Antonio De Giacomo, CC Emilio Olivieri. Sbarcata la metà degli equipaggi, tenendo a bordo solo il numero di uomini indispensabile a mantenere operativi i battelli, partirono con rotta Sud per andare ad incontrare i quattro U-Boot che stavano risalendo l’Atlantico. L’incontro avvenne al largo delle Isole di Capo Verde e sui nostri sommergibili furono trasferiti la metà dei superstiti dei due affondamenti, tutti sistemati sottocoperta, per portarli a Saint Nazaire. Il Torelli subì un attacco mentre era in rotta verso la Francia, fortunatamente senza riportare alcun danno e fu il primo a raggiungere Saint Nazaire alla fine di gennaio, seguito nel giro di un paio di giorni dagli altri tre nostri battelli. Quello che mi dispiace, è che il Comandante Rogge nelle sue memorie non ha neppure citato l’interevento dei sommergibili italiani che hanno portato in salvo lui e il suo equipaggio a Saint Nazaire. Nel febbraio 1942, non ricordo in quale giorno, l’ammiraglio Dönitz venne a BETASOM per decorare l’ammiraglio Polacchini ed i quattro comandanti ai quali venne conferita la Croce di ferro di 1ᵃ classe, mentre all’ammiraglio Polacchini fu appuntata sul petto la Croce di ferro di 2ᵃ classe. La cerimonia della decorazione dei quattro comandanti e dell'ammiraglio Polacchini In primo piano al centro l'ammiraglio Karl Donitz. A destra l'ammiraglio Polacchini. In secondo piano da destra verso sinistra i Comandanti De Giacomo, Giudice, Olivieri, Fecia di Cossato (seminascosto da Donitz) Un particolare curioso che mi ritorna in mente: a Mulin d’Ornon venivano a mangiare anche gli ufficiali tedeschi dell’ATLANTIS, che non conoscevano la nostra lingua. Sicchè, quando entravano nella mensa dicevano “malzait” che in tedesco significa “buon appetito” e i marinai italiani che, come me, erano al servizio dello Stato Maggiore rispondevano “mazzate in testa”. Io raccomandavo di stare attenti, perché qualcuno poteva capire e allora avremmo passato un guaio. Fortunatamente tutto filò liscio e dopo pochi giorni i Tedeschi rimpatriarono. -

Sommergibile S528 "pietro Venuti" - Il Giorno Del Varo
Discussione ha risposto a Chersino in una serservel nella sezione Quadrato Ufficiali
Sono dispiaciuto di non essere stato presente al varo. Chissà se e quando si presenterà un'altra occasione ... purtroppo il tempo a mia disposizione non è più molto! E' sempre vivo in me il ricordo di quello splendido 1° febbraio di quest'anno, quando insieme a tanti altri amici sono stato ospite del Cantiere del Muggiano ed ho potuto ammirare il Pietro Venuti in avanzato stato di costruzione. Che enorme differenza con il Malaspina ed i tanti sommergibili che ho avuto modo di vedere a Betasom durante la guerra! Mi unisco ad un sincero augurio di BUONA NAVIGAZIONE (speriamo sempre in tempo di pace) a questo gioiello della tecnica, al suo equipaggio ed in particolare al Comandante Giuseppe Galeandro che ricordo con infinita simpatia per come ci ha intrattenuto nell'arco dell'intera mattinata. AUGURI CARISSIMI, COMANDANTE ! ! !- 35 risposte
-
- Pietro Venuti
- varo
-
(e altri 1 )
Taggato come:
-

Chersino Racconta: Forse Sono Un Miracolato . . . .
una discussione ha aggiunto Chersino in Gli Uomini
Ero arrivato a BETASOM da pochi mesi quando la notte dell’8 dicembre 1940 avvenne il disastroso bombardamento di Bordeaux da parte degli aerei inglesi. In quell’occasione, a differenza di quanto avvenne alla città, la Base non subì seri danni: il De Grasse ne uscì quasi incolume, ma l’Usaramo, colpito in pieno da una bomba inglese, imbarcò acqua fino ad appoggiarsi sul fondo della Gironda con le sole sovrastrutture emergenti dall’acqua. L’ammiraglio Parona e lo Stato Maggiore si resero conto del pericolo che si correva a continuare a mantenere il comando e gli alloggi del personale all’interno della base. Sul De Grasse e sull’Usaramo, ormeggiato a poppa del De Grasse, alloggiavano i circa 800 uomini di stanza a BETASOM, compreso l’Ammiraglio e gli ufficiali. Inoltre c’erano anche gli equipaggi dei sommergibili al rientro dalle missioni, per cui il numero totale delle persone superava il migliaio. Tra l’altro, sul De Grasse si trovavano anche la stazione radio e l’infermeria. Inoltre, all’interno della Base, sul piroscafo Jaqueline e su alcune chiatte erano immagazzinati anche i siluri e i proiettili delle mitragliere e dei cannoni installati sui sommergibili. Se i bombardieri della RAF avessero colpito la Jaqueline saremmo saltati tutti per aria. Durante questo drammatico evento accadde un fatto che mi toccò in maniera molto personale ed ancora oggi mi emoziona moltissimo ricordarlo. Io, come l’ammiraglio Parona, gli ufficiali e gli altri marinai di stanza alla Base, alloggiavo sul De Grasse. Quella dell’8 dicembre 1940 era una notte limpida, rischiarata dalla luna piena, ma soprattutto dai bagliori dei proiettili traccianti e dallo scoppio delle bombe . In lontananza si vedevano gli incendi che divampavano nel centro di Bordeaux. Mentre sotto il bombardamento scendevo di corsa dallo scalandrone della nave, ho sentito distintamente una voce di donna che mi diceva: «Scappa, scappa!». Mi sono messo in salvo, ma il mio primo pensiero è stato che fosse la Madonna, alla quale sono da sempre molto devoto, ad esortarmi a mettermi in salvo perché alla Base non c’era alcuna presenza femminile. Oltre vent’anni più tardi – siamo negli anni ’60 – mi è capitato di andare con mia moglie in pellegrinaggio da Padre Pio a San Giovanni Rotondo; ci siamo trattenuti alcuni giorni perché, per potersi confessare da Padre Pio, occorreva mettersi in nota e attendere la chiamata. Arriva finalmente il giorno della confessione. Nella piccola cappella dove il Padre confessava, mentre ero in attesa del mio turno, percepii per ben due volte un intenso profumo di rose. Quando fui al cospetto del Frate, per prima cosa mi chiese da quanto tempo non mi confessavo. Gli risposi: «Veramente mi sono confessato ieri da un altro frate, perché, essendo trascorsi già alcuni giorni senza avere nessuna notizia su quando avrei potuto confessarmi da lei, pensavamo di tornare a casa». Padre Pio ebbe un gesto di stizza e col suo inconfondibile accento mi disse: «E che è . . . sei venuto a farmi perdere tempo?» Subito dopo si rabbonì e cominciò dicendomi, con tutt’altro tono di voce: «Ti ricordi quell’8 dicembre . . . sì, l’8 dicembre 1940. Ringrazia la Madonna, perché è stata lei che ti ha salvato». Rimasi talmente frastornato a quelle parole che non ricordo più nulla di come proseguì la confessione . . . » -

Chersino Racconta: L’Ultima Missione Del Calvi Iniziata Sotto Cattivi Auspici
una discussione ha aggiunto Chersino in Gli Uomini
Eravamo nell’estate del 1942, quindi nel momento di massima efficienza della base di BETASOM. Negli anni antecedenti l’entrata in guerra, il comandante Primo Longobardo, con il grado di capitano di corvetta, aveva comandato numerosi sommergibili. Nell’ottobre del 1940, già capitano di fregata, sostituì il pari grado Aldo Cocchia al comando del Torelli e fu in quell’occasione che ebbi modo di conoscerlo. L’ammiraglio Polacchini stava però mettendo a punto un piano di svecchiamento dei comandanti dei sommergibili, sia da un punto di vista dell’età che del grado. Il suo progetto prevedeva in quella posizione dei trentenni, col grado di tenente di vascello: secondo il suo punto di vista avrebbero avuto una maggiore prestanza fisica per affrontare le dure missioni in Atlantico e un grande entusiasmo per l’enorme responsabilità che veniva loro affidata. Il comandante Longobardo, ormai quarantenne, fu tra i primi ad essere sottoposti ad avvicendamento e nei primi mesi del 1941 venne sostituito nel comando del Torelli dal tenente di vascello Antonio De Giacomo. La nuova destinazione del comandante Longobardo fu al Comando Squadra Sommergibili presso il Ministero della Marina. Correva voce di una sua prossima promozione a capitano di vascello; prima che questo avvenisse, lui chiese insistentemente di tornare a fare almeno una missione atlantica e finalmente fu accontentato ottenendo il comando del Calvi. Fu per lui un ritorno al suo vecchio battello, che aveva già comandato durante la guerra di Spagna. Ma torniamo a quei giorni dell’estate 1942. Il Calvi era rientrato a Bordeaux dall’ultima missione in Atlantico sotto il comando del capitano di corvetta Olivieri alla fine di aprile del 1942 ed entrò in bacino per essere sottoposto ai consueti lavori di manutenzione. Frattanto il comandante Longobardo, subentrato ad Olivieri, era impegnato nella formazione del nuovo equipaggio composto in gran parte da giovani reclute al loro primo imbarco. Quando il sommergibile fu approntato per la partenza, riunì i suoi uomini e offrì la possibilità di sbarcare a chi non se la sentiva di partire per questa nuova missione. L’equipaggio al completo rispose che sarebbe rimasto con lui. Venne così il giorno della partenza e io accompagnai alla Base l’ammiraglio Polacchini e il comandante Longobardo: tutto l’equipaggio era schierato in coperta in attesa del comandante. Arrivati sotto bordo al Calvi, i due si fermarono qualche minuto a parlare in macchina ed io scesi pronto ad aprire la portiera all’ammiraglio quando il colloquio fosse terminato. Fu in quel momento che vidi un giovane guardiamarina mettere sulla torretta del sommergibile una magnolia bianca, forse in segno di festa per l’imminente partenza. Subito il direttore di macchina, un capitano del genio navale, gli urlò: «Buttala via, che porta disgrazia!» Il guardiamarina ubbidì subito e gli altri ufficiali si misero a ridere, ma forse in quel momento il destino del Calvi era già segnato. Poi il comandante Longobardo salì a bordo, furono mollati gli ormeggi e il sommergibile partì salutato, come era consuetudine, dall’ammiraglio Polacchini. Una quindicina di giorni dopo, al largo delle Canarie, le vedette del Calvi avvistarono un convoglio e Longobardo si predispose per attaccarlo, ma venne a sua volta individuato da una corvetta della scorta e costretto ad immergersi. Le bombe di profondità sganciate dagli Inglesi procurarono seri danni e il Calvi dovette riemergere. Appena in superficie subì un cannoneggiamento da parte della corvetta appoggiata da altre navi della scorta; Longobardo rispose al fuoco, ma la preponderanza degli Inglesi ebbe il sopravvento: il comandante Longobardo, l’ufficiale in seconda e molti altri membri dell’equipaggio furono falciati dal fuoco nemico; per il Calvi, che era stato immobilizzato a seguito dello speronamento da parte della corvetta che lo aveva individuato, non c’era più nulla da fare. Un ufficiale e un marinaio della corvetta salirono a bordo del sommergibile per impossessarsi del cifrario, ma nel frattempo era stato dato l’ordine di autoaffondamento e il Calvi si inabissò portando con sé tutti coloro che si trovavano al suo interno, compresi i due Inglesi. Una volta recuperati i naufraghi, il comandante della corvetta interrogò l’unico ufficiale italiano superstite e gli chiese chi era il comandante del sommergibile: «Il capitano di fregata Primo Longobardo», fu la risposta. Nel sentire quelle parole, l’ufficiale inglese sbiancò in viso ed esclamò: «Mio Dio, ho ucciso uno dei miei migliori amici! Eravamo tutti e due in Cina, a Tientsin, prima della guerra!» e così dicendo estrasse un portasigarette d’argento sul quale era incisa una dedica firmata Primo Longobardo. -
Buongiorno cari Comandanti, Ho letto solo ieri la discussione "Mi manca Chersino", al rientro in zona operativa del Com.te Max 42 che è il mio "Aiutante di Bandiera" data la mia totale ignoranza in materia di computer, e vi ringrazio per le belle parole che molti di voi mi hanno rivolto, insieme alla richiesta di conoscere altri episodi relativi alla mia permanenza a Betasom. Anch'io ho avuto qualche problema di salute quest'estate (i 94 anni cominciano a farsi sentire ...) ma ora mi sono completamente rimesso in condizioni di perfetta "navigabilità", pronto a frugare nella mia memoria per riportare alla mente qualche altro momento vissuto in quegli indimenticabili tre anni passati alla Base avendo il privilegio di servire come autista dei tre Comandanti Superiori che si avvicendarono a Betasom. Poi venne il famigerato 8 settembre 1943 e i tre lunghi anni di campo di concentramento in Germania perchè non avevo accettato di collaborare con i Tedeschi ... a differenza di altri, tra cui l'allora comandante della Base CV Enzo Grossi. Anche questa dolorosa e triste esperienza sarà oggetto di qualche mio racconto. Mi farò vivo presto sul Forum e, memore della bellissima esperienza vissuta in occasione del raduno di La Spezia per la visita al cantiere dove era in costruzione il sommergibile Pietro Venuti, che mi ha riportato ai miei vent'anni, conto di rivedervi tutti ad un prossimo raduno nazionale. Un caloroso saluto a tutti! Chersino
-

Chersino Racconta: La Corazzata Affondata Due Volte
una discussione ha aggiunto Chersino in Gli Uomini
Alla fine di Maggio del 1942 arrivò alla Base la notizia che il BARBARIGO, al comando del Capitano di Corvetta Enzo Grossi, aveva affondato al largo del Brasile una corazzata della classe MARYLAND. Nonostante l’Ammiraglio Polacchini, a quel tempo Comandante superiore di Betasom, avesse qualche perplessità sulla veridicità di questa azione (ebbi occasione di ascoltare alcuni commenti sull’argomento scambiati tra lui e il e il Tenente di Vascello Marco Revedin, a quell’epoca comandante del CAPPELLINI, il sommergibile divenuto famoso al comando di Salvatore Todaro) mentre li accompagnavo in macchina al castello di Tau, Supermarina aveva sposato in pieno la versione del Comandante Grossi, tanto che gli fu concessa la medaglia d’oro e la promozione a Capitano di Fregata. Al rientro della missione del CAPPELLINI, il Comando della Base organizzò per gli ufficiali italiani e tedeschi un grande ricevimento al Castello di Tau in onore del suo comandante. Venne servita una cena sontuosa che terminò con una enorme torta a forma di corazzata preparata magistralmente dal cuoco della mensa ufficiali, di cui non ricordo il nome, il quale da civile faceva lo chef sui transatlantici; so solo che era un Genovese. Per gli autisti che avevano accompagnato le varie autorità alla festa, tra i quali c’ero anch’io, era stata apparecchiata la tavola in una saletta al piano terreno. La cena era ormai terminata e il Comandante Grossi intratteneva gli invitati raccontando i particolari dell’azione che aveva portato all’affondamento della corazzata, ma a noi non era stata servita la torta; anzi, i camerieri avevano messo gli avanzi – era più di mezza – nel frigorifero in un locale attiguo alla cucina e se la sarebbero sicuramente divisa alla fine del servizio per portarsela a casa. A noi autisti non andava giù il fatto di non poter neppure assaggiare quell’originalissimo dolce che, tra l’altro, aveva l’aspetto di essere anche molto buono; allora ho avuto un’idea: «Perché non glielo freghiamo?». La mia proposta fu accettata all’unanimità: «Tanto, anche se ci beccano non ci fanno niente perché l’idea è stata tua e sei l’autista dell’Ammiraglio …», questa era la sicurezza di impunità che si era subito sparsa tra i miei colleghi. Detto fatto, abbiamo realizzato una specie di piramide umana montando uno sulle spalle dell’altro per salire al terrazzo sul quale si affacciava il salone. L’uomo che stava in cima alla colonna ha scavalcato il parapetto ed è arrivato al frigorifero; dopo pochi istanti è uscito portando il vassoio con i resti della torta, passandolo a quelli che stavano sotto. Si erano unite a noi anche le due sentinelle del San Marco e, tutti insieme, staccandone i pezzi con le mani, abbiamo “fatto fuori la corazzata”. Noi sì che l’abbiamo affondata! Questo episodio fu ricordato sul numero di Giugno di “Vedetta Atlantica”, il mensile di Betasom, ma non furono indicati i particolari di come avvenne il … secondo affondamento. Qui sotto posto la copia dell’articolo, scusandomi per la scarsa qualità della scansione. -
Tra i tanti momenti che ho vissuto nei tre anni trascorsi a Betasom mi piace ricordare un viaggio in Spagna svoltosi in tutta segretezza. Occorre fare una premessa. Nel marzo 1942, al rientro da una missione al largo delle coste americane, il sommergibile TORELLI subì un attacco aereo e il suo Comandante, Capitano di Corvetta Antonio De Giacomo, rimase ferito. Toccò all’Ufficiale in seconda, Tenente di Vascello Augusto Migliorini, riportare il sommergibile alla base di Bordeaux. Lì, mantenendo il grado di Tenente di Vascello, fu promosso comandante in sostituzione di De Giacomo. Nel giugno dello stesso anno, al termine di un lungo periodo di lavori, il TORELLI salpò per una nuova missione sempre al largo delle coste americane. Dopo circa 10 giorni che navigava nel Golfo di Biscaglia, fu avvistato in piena notte da un aereo inglese provvisto di radar e di un potente proiettore collocato sotto la fusoliera. Inquadrato dal fascio di luce, venne bombardato e mitragliato subendo seri danni, ma riuscì a proseguire la navigazione a lento moto verso la costa spagnola ed a rifugiarsi nel piccolo porto di Avilés. Le autorità locali concessero solo 24 ore per riparare i danni riportati e poi ripartire, altrimenti l’avrebbero internato. Da Bordeaux partì immediatamente una commissione composta dal Comandante Caridi (allora Capo di Stato Maggiore di Betasom), dal Maggiore del Genio Navale Giulio Fenu (che, tra l’altro, aveva riprogettato le torrette dei nostri sommergibili atlantici come suggerito dall’Ammiraglio Dönitz) e da un Capitano Commissario del quale non ricordo il nome, con l’ordine di far salpare in qualsiasi modo il sommergibile che non doveva assolutamente essere internato. Effettuate delle riparazioni sommarie, il TORELLI riprese il mare. Le bussole erano fuori uso e non c’era la carta nautica dettagliata della zona. Si diceva che il Comandante Migliorini avesse avuto un colpo di sonno, fatto sta che in presenza di una fitta nebbia, si andarono ad incagliare su un banco di sabbia. Il Comandante del porto offrì l’assistenza di due rimorchiatori, che venne rifiutata da Migliorini; però, qualche ora dopo, forse perché aveva visto che la marea stava montando, accettò i rimorchiatori che portarono il sommergibile in mare aperto, finchè Migliorini decise di proseguire con i propri mezzi. Pur trovandosi ancora in acque territoriali spagnole (e quindi neutrali) il TORELLI subì ben due attacchi aerei in breve successione, riportando danni gravissimi. Otto uomini dell’equipaggio finirono in mare, anzi ci si buttarono e furono recuperati da alcune imbarcazioni spagnole giunte sul posto; in un secondo tempo sostennero di averlo fatto per evitare il capovolgimento del sommergibile che era notevolmente sbandato sulla sinistra, ma si trattò evidentemente di una banalissima scusa per coprire il tentativo di abbandonare il sommergibile che appariva ormai perduto. Il Comandante Migliorini, che era rimasto lievemente ferito, era infuriato nei confronti del Comandante del porto, tanto che quando si incontrarono non gli strinse neppure la mano: lo accusava di non essere intervenuto in aiuto del sommergibile proditoriamente attaccato dagli Inglesi in acque territoriali spagnole e gli rinfacciò anche che nessuna imbarcazione spagnola era venuta in soccorso del battello così gravemente menomato. Non so esattamente come, ma il TORELLI riuscì faticosamente a raggiungere il porto di Santander, dove si adagiò su un banco di sabbia a fianco del bacino di carenaggio. Vennero effettuate le necessarie riparazioni, ma gli Spagnoli non lo lasciarono ripartire perché volevano internarlo. Alla fine di tutte queste vicende, il 12 luglio arriva a Betasom, credo tramite il Consolato Italiano di San Sebastian, la notizia che il sommergibile era nuovamente in condizioni di riprendere il mare. Però il Comandante Migliorini aveva chiesto il rifornimento d’acqua e gli era stato negato, aveva inutilmente chiesto di bunkerare perché diceva di essere a secco – invece pare avesse ancora 5 tonnellate di gasolio – anche per far vedere che non era in condizioni di scappare via. Il Capitano di Corvetta Anfossi, Aiutante di Bandiera dell’Ammiraglio Polacchini, il 12 luglio si trovava già a San Sebastian, ma io non lo sapevo. Alla sera dello stesso giorno l’Ammiraglio mi chiama e mi dice: «Fucci, te la senti di fare una missione in Spagna?» La mia risposta fu: «Signor Ammiraglio, Lei si è sempre fidato di me, però io non so parlare lo spagnolo, non ho abiti borghesi….» Mi interruppe: «Non preoccuparti; ci vai o no?» La mia risposta fu immediata: «Signor Ammiraglio, la ringrazio per la fiducia. Perché dovrei rifiutarmi?» Allora ha chiamato il Signor Aita, un giovane Guardiamarina che faceva parte dello staff del Comandante Superiore della Base e gli ha detto: «Gli procuri un vestito e domani mattina alle 6 lo faccia partire con la Ford targata RM 43¹». Poi rivolto a me: «A Biarritz troverai il Comandante Anfossi». La mattina dopo mi hanno dato una busta con dei documenti che avrei dovuto consegnare al Comandante Anfossi e a mezzogiorno, come d’accordo, mi trovo a Biarritz davanti all’albergo che mi pare si chiamasse Ritz, dove avevo appuntamento con lui. Siamo andati a mangiare nel ristorante dell’albergo e verso le 4-4 e mezza del pomeriggio partiamo diretti a San Sebastian. Dovevamo passare il confine a Irun. Arrivati a 500 metri dal confine, visto che io non avevo il passaporto, il Comandante mi chiude nel bagagliaio della macchina e si mette al volante; siamo passati dalla frontiera sorvegliata dai Tedeschi senza alcun controllo perché il Comandante Anfossi parlava molto bene il tedesco, ma anche lo spagnolo, e fece uno scambio di battute con i militari; poi dalla parte spagnola, anche lì senza alcun problema; percorsi altri 500 metri, il Comandante Anfossi si ferma per farmi uscire dal baule e mi rimetto alla guida. Arrivati a San Sebastian, saranno state le 7 di sera, mi dice: «Ricordati di questo garage che ci stiamo passando davanti. Adesso mi accompagni in albergo, io vado a rinfrescarmi un po’. Poi vieni qua, lasci la macchina nel garage, ma ricordati che ti faranno compilare una specie di formulario.» «Signor Comandante, io non so una parola di spagnolo». «Non ti preoccupare, vedrai che te lo scriveranno loro. Se ti chiedono da dove veniamo, dì che siamo arrivati da Madrid, non da Bordeaux. Mi raccomando, non parlare con nessuno perché qua ci sono molte spie inglesi». Sono andato al garage dove c’era il proprietario che effettivamente mi dice di compilare il modulo, ma io gli faccio segno che non capisco. Allora lui mi fa: «Da onde vienes?» Beh, quello l’ho capito. «Da Madrid». «Quando … (forse voleva dire te ne vai?) » «Non lo so.» Io parlavo l’italiano, non so se ha capito o non ha capito, comunque ha compilato il formulario che poi mi ha fatto firmare. Torno in albergo e lì trovo un signore distinto che mi si avvicina e mi domanda: «Dove hai portato la macchina?» «Ma quale macchina?» «La macchina, come non hai una macchina?» «No, non ho nessuna macchina, io». Ma questo insisteva: la macchina, la macchina … finchè non l’ho mandato un po’ a quel paese. In quel mentre vedo scendere dallo scalone dell’albergo il Comandante che va incontro a questo signore che subito gli dice: «Ma c’hai un autista sgarbato in una maniera incredibile … mi ha mandato in quel posto!» Il Comandante gli risponde sorridendo: «Ma, sai, la colpa è mia, lui non c’entra, è un bravo ragazzo. Gliel’ho detto io che qui ci sono molte spie inglesi e quindi di non parlare con nessuno». Solo allora il Comandante Anfossi mi disse che quel signore era il Console italiano a San Sebastian. Subito dopo il Console mi dà 5 pesetas e dice: «Vai in quel garage dove hai portato la macchina, paghi quello che devono avere, poi ritira quel foglio che ti han fatto firmare e vieni qui». Io torno al garage, ma non c’era più il titolare; c’era la moglie, almeno credo che fosse la moglie, con un bimbo di pochi mesi in una carrozzina che spingeva avanti e indietro. Dico: «Signora, io partire» e lei: «Pagare 3 pesetas». Io gliene do 5, lei mi dà il resto di 2 e poi le dico: «La carta, la carta». Lei non capiva e io ero lì che non sapevo come spiegarmi. Poi finalmente è andata a prendere quel formulario che avevo firmato, ma non me lo dava, non so per quale motivo. Io avevo la macchina in moto, le ho strappato il foglio dalle mani e son scappato a tutta velocità, tanto che a momenti metto sotto la carrozzina col bambino. Arrivo poi all’albergo e racconto al Console e al Comandante quello che mi era successo, ma loro non ci hanno fatto molto caso e mi hanno ascoltato sorridendo. Il Comandante sale in macchina col Console e mi dice: «Adesso vai a fare un giro al porto, guarda com’è la situazione, poi ci troviamo alla Taverna d’Italia», o alla Buca d’Italia, non ricordo bene, comunque era un ristorante che si trovava sotto il consolato. Verso le 9.30-10 arrivano lì, parcheggiano la macchina e insieme a loro scende una baronessa; non so come si chiamasse, ma comunque era una baronessa, molto probabilmente italiana. Ci sediamo tutti assieme per cenare e verso le 11-11.30 – perché lì si mangia tardi – ritorniamo su alla macchina e, fortunatamente, si mette al volante il Comandante; io apro la portiera alla baronessa, poi vado dall’altra parte e apro lo sportello al Console. In quel mentre saltano fuori due poliziotti con le rivoltelle in pugno, salgono sul predellino e uno di loro dice: «El coche quaranta y tres² y todos los occupantes à la comandancia.» Quello l’ho capito bene, anche se non parlo lo spagnolo. Probabilmente i poliziotti pensavano che io fossi uno dell’albergo. Comunque mi chiesero: «Usted? … Usted?» «No, no» ho detto io e sono ritornato giù nel ristorante. Quando sono arrivati in questura (la comandancia) hanno trovato la signora del garage, quella a cui avevo strappato il foglio dalle mani. Prima di andare a mangiare, il Console mi aveva fatto vedere dove era la sua villa; avrei dovuto parcheggiare la macchina nel giardino e sarei rimasto a dormire da lui, anche perché ero senza documenti e non avrei certamente potuto pernottare nell’albergo dove alloggiava il Comandante Anfossi. Ho aspettato un po’, poi sono andato alla villa del Console e mi sono fermato di fuori, seduto su una panchina perché dentro non c’era nessuno. Ho aspettato una quarantina di minuti tremando dalla paura: se fosse passata la polizia e mi avesse chiesto i documenti mi avrebbero portato difilato in galera; quelli non mi avrebbero trovato, non sapevano dove fossi ... e chissà cosa mi sarebbe successo. Finalmente arriva la macchina e parcheggia davanti alla villa; mi sono fatto coraggio, mi sono avvicinato ed erano proprio loro. Il Comandante Anfossi mi ha raccontato: «Sai chi c’era lì? Quella signora alla quale tu hai strappato il foglio dalle mani. È rimasta impappinata, perché le ho detto che sulla macchina c’ero io e non tu. Il Console si è qualificato e lei ha ritirato la denuncia scusandosi per averlo denunciato alla polizia e anche i funzionari della comandancia si sono scusati, consci di aver rischiato di provocare un incidente diplomatico». Come previsto, dopo aver parcheggiato la macchina nel giardino della villa, mi sono fermato a dormire dal Console. La mattina successiva, il 14 luglio, di buon’ora, il Console mi ha accompagnato alla sede del Consolato dove mi hanno fatto un passaporto provvisorio, quindi finalmente ero in regola. È arrivato il Comandante Anfossi e siamo partiti per Santander. Siamo arrivati attorno a mezzogiorno dello stesso giorno e siamo andati all’albergo dove alloggiava l’equipaggio del TORELLI; i marinai e gli ufficiali erano già andati a bordo. Il Comandante Anfossi ha dato al Comandante Migliorini la busta che avevo portato da Bordeaux, dopodiché, consegnandomi una pila, mi ha detto: «Tu resta all’albergo e, se vedi movimento di navi militari spagnole o qualcosa di strano nel porto, affacciati alla finestra della tua camera e fai alcuni lampi di luce, altrimenti non fare nulla». Evidentemente la busta conteneva gli ordini per il Comandante Migliorini di forzare il blocco e raggiungere Bordeaux, ma non mi hanno detto nulla in merito a questo. La giornata trascorse senza alcun movimento di navi militari spagnole nel porto. La mattina successiva, il Comandante Migliorini aveva concordato con le autorità spagnole di effettuare col sommergibile delle prove di navigazione nel porto – un ampio specchio d’acqua di forma quasi circolare che si restringeva in uno stretto passaggio all’uscita – per controllare la corretta esecuzione delle riparazioni effettuate, prima che il TORELLI venisse internato. Quindi, all’orario stabilito, con l’aiuto di due rimorchiatori, il sommergibile ha lasciato il bacino di carenaggio e si è diretto nel mezzo del bacino portuale. L’uscita era sbarrata da una cannoniera spagnola. A bordo del TORELLI si trovavano il Comandante del Porto ed un pilota. Migliorini ha chiesto al rimorchiatore di poppa di sganciarsi e di andare a recuperare una passerella per consentire all’equipaggio di lasciare il battello una volta ormeggiato in banchina. Poi ha chiesto anche al rimorchiatore di prua di sganciarsi per poter effettuare delle evoluzioni con i mezzi propri nel bacino portuale al fine di verificare che il sommergibile rispondesse perfettamente ai comandi. Il Comandante del Porto non ha avuto alcuna obiezione in merito, perché, avendo rifiutato il rifornimento di acqua e di combustibile, era certo che non sarebbe stata tentata la forzatura del blocco. Invece, come dicevo prima, a bordo c’erano ancora 5 tonnellate di gasolio ed erano state caricate, di nascosto, diverse casse di acqua minerale. Arrivato all’altezza della cannoniera, il Comandante Migliorini ha messo a tutta forza, sbracciandosi per salutare assieme ad alcuni marinai che si trovavano in coperta. Un picchetto sulla cannoniera ha risposto al saluto presentando le armi. Anziché girare attorno alla nave spagnola e tornare verso la banchina, come si aspettavano gli Spagnoli, il TORELLI ha imboccato l’uscita allontanandosi a tutta forza. Il pilota e il Comandante del Porto, che aveva cominciato ad inveire contro gli Italiani intimando di invertire la rotta furono trasbordati poco dopo su un peschereccio. La navigazione verso Bordeaux è proseguita senza intoppi e nel tardo pomeriggio dello stesso giorno il TORELLI è entrato nel bacino di Betasom, dove eravamo giunti anche noi ad aspettarlo. Infatti, subito dopo la forzatura del blocco da parte del TORELLI, io e il Comandante Anfossi siamo partiti da Santander e ho guidato quanto più velocemente possibile – questa volta avevo i documenti e mi sentivo molto più tranquillo nel caso ci avessero fermato – riuscendo ad arrivare a Bordeaux in tempo per assistere all’arrivo del TORELLI. Dopo la missione in Spagna sono stato promosso Sottocapo, mi hanno dato una medaglia al merito e una licenza di 22 giorni, l’unica di tutto il periodo trascorso a Betasom. Naturalmente non vedevo l’ora di tornare a Cherso, da dove mancavo da quando era scoppiata la guerra. Conservo ancora il foglio della licenza. Ho impiegato tre giorni ad arrivare a Cherso. A Mestre sono sceso dal treno e ho preso un autobus per andare a Venezia a casa dell’Ammiraglio Polacchini per consegnare un pacchetto che lui mi aveva dato. Poi sono montato sul primo treno in partenza per Trieste; seduta accanto a me nello scompartimento, c’era una signora che mi chiede se venivo da La Spezia. «No, vengo dall’Atlantico.» «Conosce il Comandante Tosoni Pittoni?» Alla mia risposta affermativa, la signora prosegue con un’espressione molto triste: «Io sono la sorella, noi non abbiamo più sue notizie; ci hanno detto che potrebbe essere disperso . . .». Io sapevo che era il comandante del sommergibile BIANCHI ed era stato affondato in Atlantico, ma non conoscevo i particolari; non me la sono sentita di aggiungere altra disperazione a quella che leggevo negli occhi della signora e allora le ho risposto che non ero al corrente di nulla. Giunto a Trieste, ho cambiato treno e sono arrivato a Fiume dove mi sono fermato a dormire la notte. Il giorno dopo ho preso il piroscafo per andare a Cherso, così ho impiegato tre giorni e due notti per tornare a casa. Se avessi dovuto viaggiare in tradotta chissà quando ci sarei arrivato! Siccome ero “autista di lusso”, sul foglio della licenza mi hanno scritto “autorizzato a viaggiare su treni diretti e direttissimi perché al seguito di un ufficiale superiore (anche se questo non era vero). Così a Cherso ho passato questi 22 giorni e poi ho trovato la scusa che mi faceva male la pancia. Allora il Tenente Fresa, Comandante della Capitaneria, che mi conosceva già da prima quando io ed un mio amico avevamo fatto la “scappatella” a Cherso proprio alla vigilia della dichiarazione di guerra, mi ha firmato la proroga della licenza per malattia e mi sono rimesso in viaggio per Bordeaux. Siccome ero già in ritardo, non sono riuscito a fare una sosta in Germania per andare a trovare una ragazza che avevo conosciuto in treno durante il viaggio di andata. Cosa vuole mai, quella volta avevo vent’anni e si marciava alla grande! ¹ Era una Ford recuperata dal DE GRASSE, ritargata RM (Regia Marina) 43. ² L’auto 43 e tutti gli occupanti in questura. Biglietto di Licenza (fronte) – Notare in alto a sinistra l’autorizzazione a viaggiare su treni diretti e direttissimi firmata dal Guardiamarina Raffaele Aita. In alto a destra la rettifica circa il rilascio dei buoni viveri per giorni 10 “NON SONO STATI RILASCIATI BUONI VIVERI PERCHE’ QUESTO COMANDO NE E’ SPROVVISTO”. In basso a destra, in corrispondenza del timbro del C.F. Giuseppe Caridi appare la firma del Tenente del C.R.E.M. Luciano Penelope. Biglietto di Licenza (retro) – Notare i vari timbri “Visto arrivare” “Visto partire”. In fondo a destra la concessione di giorni 7 di proroga firmata dal Tenente di Porto Giuseppe Fresa.
-

Chersino Racconta – La Prima Missione Atlantica Del Malaspina
una discussione ha aggiunto Chersino in Gli Uomini
Ho ricevuto la cartolina di precetto a Cherso e mi sono presentato al Deposito C.R.E.M.¹ di Pola, dove ho prestato giuramento, dopodiché ai primi di giugno ho fatto una “scappatella” a Cherso: dopo aver fatto il giuramento, con un altro mio amico che era stato richiamato siamo arrivati a Cherso e c’era il Comandante Fresa in Capitaneria, però lui non sapeva se eravamo in permesso o no; sta di fatto che il 10 giugno del ’40, mentre ci trovavamo a casa, è scoppiata la guerra e avevano interrotto la linea marittima che collegava Cherso a Porto Albona col piroscafo ORSINI; quindi non potevamo rientrare e avevamo paura di venire scoperti ed essere condannati per diserzione. Invece, fortunatamente, al pomeriggio il piroscafo è ripartito e noi alla sera siamo rientrati a Pola in Deposito. Io ero l’ordinanza del Tenente Bicchierai che mi aveva dato un permesso per andar fuori e rientrare senza limiti d’orario; quell’altro, anche lui doveva rientrare in deposito ma non fu effettuato alcun controllo, per cui quella volta era andata liscia. Dopo qualche tempo ho avuto il trasferimento dal Deposito di Pola alla Casermetta Sommergibili di La Spezia. Nell’arsenale era in allestimento il MALASPINA² ed io venni imbarcato con la qualifica di Marò servizi vari. Dopo alcuni giorni passati ad effettuare collaudi nello specchio di mare antistante La Spezia, il 29 luglio siamo salpati per destinazione ignota. Trascorsi un paio di giorni, stavamo ancora navigando nel Mediterraneo, il Comandante – Capitano di Fregata Mario Leoni – ci ha detto che non saremmo rientrati in Italia, ma avremmo fatto rotta su un porto estero. Nei pressi di Gibilterra abbiamo avvistato un cacciatorpediniere che dirigeva dritto verso di noi. Il Comandante ha dato ordine di rapida immersione, perché comunque, per non essere avvistati, lo stretto di Gibilterra doveva essere attraversato in immersione. Probabilmente il cacciatorpediniere non ci aveva scorto, perché non avvenne alcun lancio di bombe di profondità; sta di fatto sta che mentre navigavamo nel bel mezzo dello Stretto, improvvisamente il MALASPINA, forse a causa delle correnti particolarmente forti che si formano due o tre volte al mese, non rispondeva più ai comandi e cominciò ad appruarsi in una discesa inarrestabile verso il fondo. Nessuno riusciva ad intervenire, perché l’angolo di appruamento era così forte che era impossibile stare in piedi; tutto ciò che non era rizzato cadeva a pagliolo: un vero rovinio di oggetti. I macchinisti, a causa del pavimento scivoloso della sala macchine, furono i primi a perdere l’equilibrio. Il Comandante, che si era legato al cavo del periscopio, dava gli ordini, ma nessuno era in grado di eseguirli. Ci arrestammo infine alla profondità di 170 m., con i vetri dei manometri che scoppiavano per l’enorme pressione cui erano sottoposti, dal momento che il sommergibile era stato progettato per raggiungere la profondità massima di 125 m. Fu data aria ai doppi fondi e alle casse di zavorra, ma senza ottenere alcun risultato. Noi marinai, tutti al primo imbarco, eravamo impietriti, ed avevamo la certezza che avremmo fatto la fine del topo in trappola. Avevamo paura anche di restare senza energia elettrica, perché un’eventuale deformazione dello scafo avrebbe provocato l’interruzione della corrente elettrica ed immobilizzato definitivamente il MALASPINA; allora sarebbe stata davvero la fine. Che io sappia , dopo che era stata data aria ai doppi fondi e alle casse di zavorra senza ottenere alcun risultato immediato, non fu effettuata nessun’altra manovra. Come Dio volle ad un certo momento il sommergibile si rimise in assetto, cominciò lentamente a risalire ed a rispondere ai comandi. Probabilmente anche l’intensità della corrente nello stretto era diminuita, ma per me – e credo anche per tutti gli altri – il ritorno alla navigabilità del MALASPINA resta un fatto inspiegabile. Il Comandante Leoni arrestò la risalita ad una profondità di 50 m., quindi proseguimmo la navigazione in immersione verso l’Atlantico. Il giorno 3 agosto siamo finalmente riemersi in Atlantico e abbiamo cominciato la nostra prima missione girovagando per l’oceano circa 35 giorni (adesso non ricordo esattamente dato il lunghissimo tempo trascorso). Abbiamo fermato alcune navi che risultarono tutte appartenenti a nazioni non belligeranti, però noi andavamo ugualmente a bordo per ispezionarle, in quanto avrebbero potuto trasportare armi o materiali di contrabbando per il nemico. Non trovammo mai nulla di sospetto e quindi le lasciammo andare raccomandando che non segnalassero il nostro incontro; però non potevamo sapere se avevano avvisato o no via radio, ma in effetti nessuna nave o aereo nemico ci dette mai la caccia. Ormai pensavamo di arrivare a Bordeaux senza portare alcun risultato, invece un certo giorno (credo che fosse il 12 o il 15 agosto), mentre navigavamo a quota periscopica, abbiamo avvistato una petroliera di grosso tonnellaggio in lontananza e il Comandante accertò che batteva bandiera inglese. Fece inviare un messaggio a lampi di luce intimando di fermarsi. Dalla BRITISH FAME – questo era il nome della petroliera – ci spararono contro con il cannone di bordo. A questo punto il Comandante lanciò quattro siluri, riuscendo ad immobilizzarla ma non ad affondarla. Intanto dalla nave venivano calate le scialuppe sulle quali si erano imbarcati gli uomini dell’equipaggio (credo che tre di loro siano morti) e, non appena le lance si allontanarono dalla nave, l’affondammo a cannonate. Prendemmo a bordo il capitano della petroliera (mi pare si chiamasse Knight) e il marconista. Durante l’interrogatorio di quest’ultimo, il Comandante Leoni gli chiese se avesse segnalato il nostro attacco. La risposta fu affermativa, anche se non era sicuro che il messaggio fosse stato ricevuto correttamente, in quanto trasmesso con la radio d’emergenza essendo andata distrutta la stazione principale. Nonostante questa incertezza, dopo aver trasferito il marconista su una scialuppa, il Comandante Leoni prese a rimorchio per un giorno e una notte le tre lance della BRITISH FAME con i superstiti; il mattino successivo, dopo essersi assicurato che i naufraghi avessero scorte sufficienti di cibo e acqua, dette ordine di mollare la cima a circa 100 miglia dalle Isole Azzorre, dove l’equipaggio della petroliera giunse sano e salvo. Il Capitano, invece, rimase prigioniero a bordo del MALASPINA per i successivi 15 giorni, cioè fino al nostro arrivo a Bordeaux, dove lo consegnammo ai Tedeschi perché noi non avevamo campi di prigionia in Francia. Rimase però un grande amico del Comandante Leoni, arrivando a dire, dopo solo pochi giorni trascorsi sul nostro sommergibile, che l’affondamento della sua nave era servito, se non altro, a fargli conoscere che gente fossero gli uomini di mare italiani. Cessato il conflitto, i due Comandanti si scambiarono visita più volte in Inghilterra e in Italia. Però il comportamento umanitario del Comandante Leoni non piacque ai Tedeschi, tanto che il Contrammiraglio Karl Dönitz che, da Parigi dove si trovava il Comando in capo dei sommergibili tedeschi con il compito di coordinare anche le missioni di quelli italiani, era venuto a ricevere il primo sommergibile italiano giunto a Bordeaux il 4 settembre, gli fece una dura reprimenda dicendogli che se fossero stati gli Inglesi ad avere la meglio sugli Italiani, non li avrebbero certamente rimorchiati, ma li avrebbero buttati a fondo. Tra le altre cose, Dönitz rinfacciò a Leoni che per fare un sommergibile ci vogliono sei mesi o un anno e per fare un uomo occorrono vent’anni, per cui, con il suo comportamento, aveva messo a repentaglio un capitale umano di enorme valore, oltre allo stesso battello. Al che Leoni rispose: «Signor Ammiraglio, la nostra civiltà, a differenza di altre, c’impedisce di infierire sul nemico quando è ormai indifeso». Mi preme ricordare che allora l’Ammiraglio Dönitz era il comandante della flotta di sommergibili tedeschi che operavano in Atlantico. Fu lui ad ideare la tecnica di attacco del “branco di lupi”. In pratica ciò avveniva nel modo seguente: quando un sommergibile avvistava un convoglio, o comunque una nave nemica, mandava un messaggio cifrato al Comando di Parigi segnalando la posizione del bersaglio. A sua volta il Comando faceva confluire sul posto tutti i sommergibili che si trovavano nell’area di mare circostante, come un branco di lupi. L’attacco avveniva sempre in superficie e di notte con un lancio incrociato di siluri eludendo la difesa dei cacciatorpedinere che scortavano il convoglio. Pensi che nel 1940 gli Inglesi e gli Americani arrivarono a perdere fino a 400.000 tonnellate di naviglio al mese e infatti gli Americani si diedero a costruire ad un ritmo impressionante i famosi Liberty di cemento³. Il giorno successivo al nostro arrivo, il MALASPINA entrò in bacino di carenaggio per verificare la causa degli inconvenienti manifestatisi nello stretto di Gibilterra e, contemporaneamente, seguendo il consiglio dell’Ammiraglio Dönitz, per ridurre le dimensioni della torretta e dei periscopi. Infatti, il 4 settembre, quando vide il battello, disse: «Questa torretta sembra un castello, è troppo visibile. Se non le rimpicciolite, ve le buttano giù come birilli, e insieme a loro anche i sommergibili!» Al termine dei lavori, che si protrassero per tre mesi, Dönitz tornò a Betasom per vedere le modifiche che erano state apportate al MALASPINA. In sostanza, l’Ammiraglio tedesco voleva rendersi conto di persona come stavano le cose sui nostri sommergibili, perché i rapporti che riceveva dai suoi ufficiali non erano affatto rassicuranti. Era convinto che sia gli uomini che i loro equipaggiamenti mostrassero parecchie carenze. L’addestramento ricevuto dai comandanti ignorava completamente la tecnica di attacco “del branco di lupi”, cosa che lui giudicava molto criticabile e poi gli era stato riferito che il vestiario di navigazione degli equipaggi non era idoneo ad affrontare le condizioni di tempo e di mare che si riscontravano in Nord Atlantico. Durante la visita, Dönitz chiese al Comandante Leoni come era composto l’equipaggiamento del personale. Allora Leoni fece schierare in coperta l’equipaggio con la tenuta di navigazione, che in effetti era molto simile a quella dei marò del San Marco, in panno di colore grigioverde scuro. In caso di cattivo tempo, i marinai di vedetta indossavano una specie di mantella di panno con un cappuccio molto largo. La mantella era legata in vita con un cordone, mentre il cappuccio si stringeva attorno al viso con uno spago. La reazione di Dönitz fu piuttosto incredula e concordò con l’Ammiraglio Parona che il MALASPINA avrebbe dovuto ritardare la partenza di qualche giorno, in attesa che dalla Germania fosse inviato l’equipaggiamento idoneo ad affrontare le tempeste invernali del Nord Atlantico. Infatti, tre giorni dopo arrivò un treno carico di indumenti: stivaletti imbottiti, giacconi e pantaloni di pelle rivestiti internamente di lana, incerate e sud-ovest⁴ per gli uomini di vedetta quando c’era cattivo tempo e infine i binocoli Zeiss che davano una migliore definizione dell’immagine rispetto ai nostri Salmoiraghi. Però, nel frattempo, io ero diventato l’autista dell’Ammiraglio, come ho già raccontato in “Ricordi di un Chersino a Betasom” inviato il 14 gennaio 2014 e così iniziò per me una nuova esaltante esperienza. Quando vidi allontanarsi il MALASPINA dalla banchina della Base fui preso da un senso di profonda tristezza, sentendomi quasi in colpa per non essere tra i miei compagni della prima avventurosa missione di questo sommergibile. Chissà se li avrei mai rivisti! ¹ C.R.E.M. è l’acronimo di Corpo Reali Equipaggi di Marina. Equipaggi di Marina ² Il Regio sommergibile MALASPINA era un battello oceanico appartenente alla classe MARCONI. Fu impostato il 1° marzo 1939 nei cantieri OTO di La Spezia, varato il 18 febbraio 1940 ed entrò in servizio il 20 giugno dello stesso anno. Scomparve senza dare più notizie nel settembre 1941. Dislocava in emersione 1.191 t. e in immersione 1.489 t. Lunghezza 70,04 m. Larghezza 6,82 m. Pescaggio 4,72 m. Profondità operativa 100 m. Propulsione: 2 motori diesel CRDA, potenza complessiva 3.250 HP; 2 motori elettrici Marelli, potenza complessiva 1.500 HP. Autonomia: 10.500 miglia a 8 nodi in superficie; 110 miglia a 3 nodi in immersione. Equipaggio: 7 Ufficiali, 50 Sottufficiali e Comuni. Armamento: 1 cannone da 100/47 Mod. 1938; 4 mitragliere AA Breda Mod. 31 da 13,2 mm. (2 delle quali binate); 8 tubi lanciasiluri da 533 mm con dotazione di 16 siluri; mine. ³ In realtà il governo americano, a livello sperimentale, a partire dal luglio 1943 commissionò ad un cantiere di Tampa (Florida) solamente 24 Liberty di cemento armato. Esse furono inviate in Europa e utilizzate per lo sbarco in Normandia. Due di queste navi vennero autoaffondate di fronte alla costa francese per creare una sorta di barriera frangiflutti. Viceversa le Liberty tradizionali in acciaio (furono le prime navi completamente saldate per velocizzarne la costruzione), rappresentano ancora oggi la più numerosa classe di navi mai costruita: tra il 1941 e il 1945 ne furono varate ben 2.710 (2.580 modello base, 24 carboniere, 8 trasporto carri armati, 62 cisterne, 36 trasporto aerei). Le Liberty venivano assemblate in 18 cantieri navali ubicati sia sulla costa atlantica degli USA che su quella del Pacifico. Una miriade di cantieri minori producevano sezioni grandi e piccole delle navi, che poi venivano mandate ai cantieri principali per il montaggio. Le sezioni relative agli alloggi, ad esempio, arrivavano già complete degli arredamenti, così pure il ponte di comando giungeva con le strumentazioni nautiche già installate. Si trattava in definitiva di navi semplici, lunghe f.t. 134,57 m. con stazza lorda di 14.245 tons. Erano state eliminate quanto più possibile le strutture curve per semplificare le operazioni di assemblaggio e saldatura (lo scafo era in sostanza un enorme cassone con forme affusolate a prua e a poppa); la coperta, in acciaio rinforzato per sopportare carichi pesanti che non trovavano posto nelle stive, era continua e spianata, con assenza di castello di prua e cassero di poppa; era presente una sola sovrastruttura su tre livelli nella parte centrale, contenente gli alloggi molto spartani. Le stive erano 5, tre a proravia del cassero centrale e due a poppavia. La motrice era una macchina a vapore a triplice espansione da 2.500 HP, con caldaie a tubi d’acqua alimentate ad olio combustibile ed elica a 4 pale; la manutenzione della macchina e delle caldaie era molto semplice, in modo da non richiedere un’elevata specializzazione del personale. La velocità massima era di 11 nodi; alla velocità di crociera di 10 nodi l’autonomia era di 14.000 miglia. L’equipaggio era composto da circa 40 uomini della marina mercantile più una ventina di artiglieri, mitraglieri e addetti alle comunicazioni della US Navy. L’armamento era composto da un cannone da 102 mm. a poppa – ma spesso ve ne era anche uno da 152 mm a prua – e da 8 postazioni di mitragliatrici a/a da 20 mm. La forma dello scafo, molto capiente ma assai poco marina, rendeva le Liberty particolarmente soggette al rollio anche con mare non eccessivamente agitato. La nuova tecnica di saldatura delle lamiere, anziché la classica chiodatura, creò seri problemi per le sollecitazioni cui le navi, spesso sovraccaricate, erano sottoposte durante le violente tempeste invernali del Nord Atlantico. Prima che si ponesse rimedio a questo inconveniente, ben 8 Liberty si spezzarono in due all’altezza del ponte di comando ed affondarono. Nel corso del conflitto andarono perse circa 300 unità. Delle restanti, 835 furono vendute alle marinerie di numerosi Paesi, tra cui l’Italia che, grazie a queste navi, fu in grado di iniziare la ricostruzione della propria flotta mercantile andata pressoché totalmente distrutta a seguito degli eventi bellici. Le altre furono messe “in naftalina” dalla US Navy e di volta in volta utilizzate per i trasporti logistici durante la guerra di Corea e quella del Vietnam. ⁴ Il sud-ovest è un cappello impermeabile usato nelle marine mercantili e militari con una grande tesa posteriore che si sovrappone al collo dell’incerata per evitare che la pioggia o gli spruzzi di mare si insinuino al suo interno. All'epoca di Betasom e oggi ... Ahi l'ingiuria del tempo! Al C.R.E.M. di Pola poco dopo il Giuramento Il MALASPINA ormeggiato nel bacino a livello costante di Betasom Sulla banchina di Betasom lungo la Garonna - A sinistra spunta il muso della SIMCA 1100 -

Xvi Raduno "smg Venuti" - I Rapporti Da Spezia
Discussione ha risposto a Chersino in una Totiano nella sezione La Nostra Scia
Cari Comandanti, Il Raduno del Muggiano è stata la prima occasione per conoscere molti di voi e il meraviglioso ambiente di Betasom (sono socio da pochi mesi e prima che il Comandante Max42 me ne parlasse, non ne conoscevo l'esistenza ... cosa vuol dire avere quasi 94 anni!!! La giornata di ieri è stata per me un momento felice, che mi ha riportato indietro di 74 anni, quando sono arrivato a Bordeaux nel 1940 col MALASPINA. Sentire i nomi e rievocare i personaggi che hanno reso famosa ed eroica la base di Betasom (di cui purtroppo oggi non parla nessuno, come se il sacrificio dei nostri sommegibilisti che giacciono in fondo all'Atlantico nelle loro bare d'acciaio non fosse avvenuto) mi ha fatto tornare alla mente tanti momenti ed episodi che ho vissuto nei miei tre anni di permanenza alla Base prima che i Tedeschi mi facessero prigioniero l'8 settembre 1943 e cominciasse per me una lunga, dolorosa avventura nei campi di concentramento. Vi confesso di essermi emozionato e commosso quando ho potuto abbracciare Capo Ghezzi (e rievocare con lui durante il pranzo le vicende del CAPPELLINI e la personalità del suo eroico Comandante), ma anche la Signora Todaro e il nipote dell'Ammiraglio Romolo Polacchini. Come forse avete avuto modo di leggere nella sezione "Discussioni a tema - Storia - Gli uomini" il mio post "Ricordi di un Chersino a Betasom", dopo essere arrivato a Bordeaux col MALASPINA sono stato designato a svolgere la mansione di autista per i tre Comandanti superiori della Base che si sono alternati. Però il mio ricordo più affettuoso va all'Ammiraglio Polacchini che mi ha trattato come un figlio, dandomi tanti insegnamenti e consigli che si sono rivelati preziosi in seguito. Un episodio per tutti: quando fu trasferito da Bordeaux per assumere un altro comando in Italia, mi propose di andare con lui, ma non me la sentii di lasciare la Base, anche perche' questioni di cuore mi legavano a Bordeaux .... invece poi venne il Comandante Grossi e fu tutta un'altra cosa. Voglio ringraziare tutti per la calorosa accoglienza che mi è stata riservata, molto al di la' delle mie aspettative e sicuramente largamente immeritata. Spero di avere ancora la possibilità di partecipare (Dio permettendo) ad altri raduni e di continuare a far parte di questa nostra grande famiglia. Vi abbraccio tutti. Andrea -

Relazione Del Cc Walter Auconi Su Missione Del Cappellini
una discussione ha aggiunto Chersino in Quadrato Ufficiali
Ecco la prima pagina relazione scritta dal C.C. Walter Auconi, comandante del sommergibile Cappellini, sull'ultima missione effettuata in Estremo Oriente dal suo battello carico di merce destinata al Giappone, con dedica al C.te Chersino ---------------------- ------------------------- ----------------- ---------------------- --------------- --------------------------